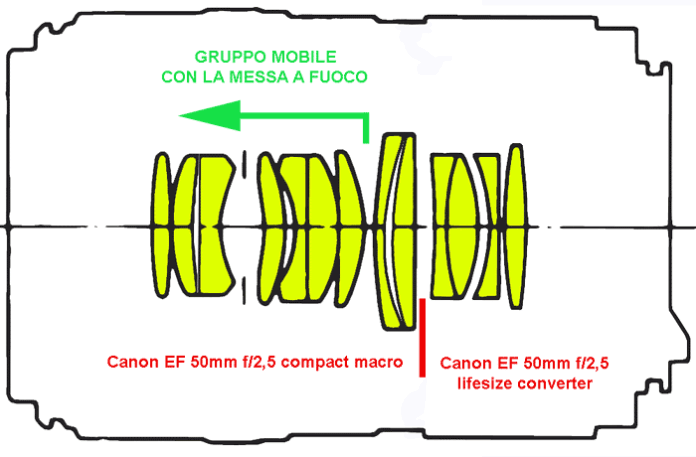Quando si porta un obiettivo a distanze ravvicinate, le aberrazioni cambiano in modo sensibile: aumenta la curvatura di campo, compaiono più marcatamente astigmatismo e sferica, e la cromatica longitudinale tende a crescere. La ragione è fisica: spostando il piano di fuoco, il bilancio dei contributi dei diversi elementi e delle superfici non resta costante, e un progetto ottimizzato “a infinito” degrada via via che ci si avvicina al soggetto. È un problema classico dell’ottica (le cosiddette aberrazioni di Seidel), ben formalizzato tanto in didattica universitaria quanto nelle note applicative industriali, e che pone limiti concreti alla MTF e alla resa ai bordi, proprio là dove la macro pretende uniformità su sensori densi.
La risposta progettuale è il floating group o gruppo ottico flottante: una o più sotto-unità di lenti che, durante la messa a fuoco, non si limitano a traslare solidalmente con il resto del blocco ottico, ma variano la distanza relativa rispetto alle altre, con cinematismi dedicati (camme, helicoidi sdoppiati, treni a cremagliera) in modo da compensare l’evoluzione delle aberrazioni al cambio di tiraggio. Il principio è semplice nella sua idea, complesso nell’esecuzione: si “disaccoppia” la messa a fuoco dalla correzione, introducendo un grado di libertà in più che permette di rimodellare il fronte d’onda quando la scena si sposta verso il MOD (minimum object distance). Documentazione industriale recente di Zeiss lo sintetizza bene: il floating elements design “compensa le aberrazioni alle diverse distanze” modificando l’interasse assiale di specifici gruppi ottici mentre si focheggia.
Storicamente, il linguaggio e le soluzioni sono nati nel grande sforzo di far funzionare bene i grandangolari retrofocus alle distanze corte, ma sono presto migrati dove l’esigenza è strutturale: la macrofotografia. Un momento chiave è il programma CRC (Close Range Correction) di Nikon, inaugurato con il NIKKOR‑N Auto 24mm f/2.8: è il “primo obiettivo dotato di meccanismo di correzione a distanza ravvicinata”, come racconta la serie ufficiale NIKKOR – The Thousand and One Nights, nata proprio per affrontare la variazione delle aberrazioni in prossimità. Il documento ingegneristico spiega che, in retrofocus veloci, l’astigmatismo cresce marcatamente a distanza breve e la soluzione fu introdurre gruppi flottanti che si muovono secondo leggi proprie durante la focheggiatura.
Canon adotta formalmente la stessa idea nei primi anni Settanta: nel 1973 il FD 35mm f/2 S.S.C. (I) viene presentato dal Canon Camera Museum come il “primo grandangolare Canon con meccanismo flottante”, che sposta una parte dell’ottica separata dal gruppo di messa a fuoco per ridurre l’aumento di astigmatismo alle brevi. È una definizione cristallina della logica del floating: non tutto il pacco lenti si muove insieme.
In parallelo, Zeiss adotta e codifica l’acronimo FLE (Floating Lens Element) in più linee, dai Distagon medio formato agli attuali Batis, indicando un disegno con elementi “galleggianti” che mantengono costante la correzione lungo il range distanze. Anche nelle ottiche Hasselblad V con ghiera dedicata FLE, l’utilizzatore può impostare manualmente la zona di lavoro (per esempio 0,8–0,5 m), “accordando” l’obiettivo per ottenere prestazioni ottimali a infinito come in close‑up.
Il perché il floating diventi vitale in macro risiede nell’ampiezza delle variazioni geometriche: quando si cerca il 1:1, il sistema opera ben lontano dal punto di ottimizzazione a infinito. Manuali e testi tecnici ricordano che la curvatura di campo e la sferica sono i primi colpevoli del calo ai bordi; la compensazione dinamica dei gruppi consente di “raddrizzare” il campo e contenere la sferica anche a diaframmi medi, preservando nitidezza e contrasto sul fotogramma.
Altre innovazioni si intrecciano a questa: il focus interno (IF) riduce le masse in movimento e non allunga il barilotto, ma introduce un effetto collaterale noto come accorciamento di focale a distanza ravvicinata (e relativo focus breathing), proprio perché per mettere a fuoco “dentro” il gruppo si modificano i contributi di potenza dei singoli blocchi. Enciclopedie e manuali sottolineano come l’IF mantenga il barilotto stabile e favorisca l’uso di paraluce e flash anulari, ma ricorda anche che la focale “vera” decresce via via che ci si avvicina, con impatto su inquadratura ed apertura effettiva.
In questo quadro, il gruppo flottante è la leva progettuale che, insieme a IF e alle moderne soluzioni di coatings e vetri a bassa dispersione, permette all’ottica macro moderna di offrire prestazioni uniformi dal medio‑infinito al mondo vicino a 1:1. L’idea è maturata storicamente su grandangolari e poi si è rivelata strutturale nei macro, dove l’intero progetto deve “vivere” più vicino al sensore, e dove la minima variazione nella sfera d’onda si traduce in perdita di risoluzione percepibile su sensori fitti.
Implementazioni nelle ottiche macro: dal Micro‑Nikkor al 100 mm Canon
Se si guarda alla genealogia delle macro, Nikon usa il nome Micro‑Nikkor fin dagli anni Cinquanta; la pagina storica ufficiale ricostruisce il percorso dal 5 cm f/3.5 (1956) per S‑mount, ottimizzato per riproduzioni, fino al passaggio ai 55 mm per l’F‑mount e alle focali più lunghe, con l’idea cardine di raggiungere almeno 1:2 nativo e una resa controllata sull’intero campo. È significativa la doppia tradizione: da un lato obiettivi “da laboratorio” per documentazione tecnica, dall’altro macro “universali” per reflex a specchio.
La transizione dai primi 55mm f/3.5 ai 55/2.8 AI‑s è un buon caso di scuola. Le cronache di sviluppo delle Thousand and One Nights dedicano un doppio episodio alla nascita dei Micro‑Nikkor e alla spinta, tipicamente nipponica, per distinguere “macro” da “micro” secondo una definizione rigorosa basata sul rapporto di riproduzione. La successiva introduzione della CRC nei macro corti migliora sensibilmente la resa a distanza minima, segno che l’idea del floating non resterà confinata ai grandangolari.
Sul piano pratico, anche i test indipendenti dei 55mm storici mostrano il quadro atteso: resa elevata già da f/5.6, ottimo comportamento al centro e buon controllo di cromatica sull’asse fino a 1:2, con un decadimento ai bordi che, senza un floating spinto, costringe a diaframmi più chiusi man mano che si va a rapporti oltre 1:2 con tubi. È la fotografia di un’epoca in cui il macro “vero” si faceva spesso con estensioni, e i compromessi di campo e sferica si gestivano più a diaframma e metodo che a progetto.
L’evoluzione successiva porta alla stagione degli IF Macro con flottanti integrati. Canon fa scuola con l’EF 100mm f/2.8 Macro USM (2000): il museo ufficiale precisa che, “per la prima volta in un tele macro 1×”, viene utilizzata una messa a fuoco interna, mantenendo costante la lunghezza del barilotto, preservando distanza di lavoro e non ruotando la filettatura frontale; soprattutto, il progetto adotta una messa a fuoco a tre gruppi flottanti indipendenti, proprio per contenere le variazioni di aberrazione lungo tutto il range da infinito a 1:1. È l’esempio didattico di cosa si intenda per gruppo flottante “progettuale” e non solo “meccanico”: tre sotto‑sistemi con leggi di moto diverse, orchestrati per mantenere costanti i compromessi.
Nel mondo Nikon, l’AF‑S VR Micro‑Nikkor 105mm f/2.8G IF‑ED porta lo stesso paradigma sull’ammiraglia macro autofocus: IF dichiarato, VR per stabilizzare il mirino e l’inquadratura, vetri ED per la cromatica, e—fattore chiave per il nostro tema—una cinematica interna che, pur non esplicitando nel nome “CRC”, cambia le spaziature interne durante la messa a fuoco. Il materiale ufficiale Nikon conferma l’IF e l’impostazione di progetto; le recensioni tecniche sottolineano come a distanza ravvicinata si avverta focus breathing marcato, ossia una variazione apparente dell’ingrandimento quando si focheggia, effetto collaterale della accorciata di focale tipica degli IF, che il fotografo impara a gestire con stilemi pratici (AF‑C e micro movimenti del corpo).
Per capire quanto il floating sia strutturale, basta guardare alle specifiche geometriche in macro. A 1:1, l’ottica richiede, in un mondo ideale a gruppo solidale, due focali di estensione e un conseguente calo di apertura effettiva di circa 2 stop; nelle soluzioni IF+FLE l’apertura effettiva scende comunque e la focale reale si riduce, ma in cambio si controllano campo e sferica mantenendo la nitidezza ai bordi a livelli da sensore moderno. Discussioni tecniche e spiegazioni di manuale ricordano che alcune fotocamere espongono in EV già corretti (Nikon visualizza il numero f effettivo in macro), altre no; il progettista, con il floating, sposta la fatica dall’utente (chiudere molto il diaframma, con rischio di diffrazione) al disegno, mitigando la necessità di fermarsi oltre f/16–22.
Non è solo teoria: Canon, con l’EF 100mm f/2.8 Macro USM citato, dichiara precisamente che l’inner focusing consente piena compatibilità con sistemi macro flash frontali e che il “three‑group floating focusing” minimizza le variazioni di aberrazione legate alla distanza. È un linguaggio che, messo in pratica, si traduce in MTF più piatte tra infinito e 1× e in una costanza di resa “clinica” su campi piatti, dal documento al sensore.
I limiti? Il rovescio della medaglia del floating e dell’IF è proprio l’effetto respirazione e la variazione di focale che può rendere “elastico” il rapporto di riproduzione rispetto alla ghiera distanza. La letteratura di settore lo ammette: si guadagnano maneggevolezza e sigillatura, si rinuncia a un comportamento “geometrico” da banco ottico. È il compromesso naturale del macro moderno, in cui il progettista sceglie di privilegiare correzione e praticità a scapito della rigidezza geometrica pura.
Implicazioni pratiche, manutenzione, progettazione moderna e genealogie industriali
Dal punto di vista di chi fotografa, un macro con gruppo flottante ben implementato offre tre vantaggi misurabili. Primo, costanza di nitidezza ai bordi in close‑up reale; secondo, campo più piatto—una benedizione su soggetti come documenti, circuiti stampati, minerali; terzo, coerenza cromatica lungo il frame, poiché la cromatica longitudinale, che aumenta avvicinandosi, viene arginata dalla riconfigurazione interna dei gruppi. I materiali di riferimento sull’ottica fotografica mostrano come una porzione significativa delle perdite di qualità in macro derivi proprio da sferica e curvatura, due aberrazioni che il floating aiuta a “inseguire” durante la focheggiatura.
Sul banco di progetto, il floating impone meccaniche più raffinate, tolleranze strette e allineamenti più critici. I laboratori che “rehousano” ottiche cinema descrivono l’aumento di complessità dovuto al dover muovere due o tre gruppi a rapporti diversi e, talvolta, in direzioni opposte: cresce la potenzialità di prestazione, ma anche l’onere di taratura e l’attenzione alla coassialità. È il prezzo per portare un obiettivo, ottimizzato a infinito, a comportarsi come “due progetti in uno”: uno da vicino, uno da lontano.
L’impatto di queste soluzioni ha riverberato anche fuori dalla macro. Un caso celebre è il Leica Summilux‑M 35mm f/1.4 ASPH (2010), in cui l’introduzione del gruppo flottante—Leica lo dichiara esplicitamente nella scheda tecnica—serve a mitigare il focus shift alle brevi e a mantenere alte le prestazioni “da minima a infinito”, un linguaggio concettuale identico al macro, applicato però a un grandangolare luminoso. È la dimostrazione che il floating è diventato uno strumento generalista di controllo delle aberrazioni variabili con la distanza.
Per completezza storica — richiesta inevitabile in un “profilo” di tecnologia su un Wiki — conviene fissare alcune date fondamentali dei marchi che hanno reso concreta questa filosofia progettuale. Nikon nasce nel 1917 come Nippon Kōgaku, consolidando in un’unica realtà tre produttori di ottica e diventando, nel tempo, una casa nota sia per strumenti di misura sia per fotografia; la pagina ufficiale corporativa ricostruisce il secolo di storia e l’evoluzione del marchio fino al naming “Nikon” del 1988.
Canon viene formalmente fondata nel 1937 (le radici sono nel laboratorio del 1933) e documenta nel proprio archivio i passaggi dagli anni Trenta all’era EF, includendo la stagione FD in cui codifica il “floating mechanism”.
Zeiss ha origine nel 1846 a Jena: l’Archivio ufficiale ripercorre la biografia di Carl Zeiss (1816–1888) e l’evoluzione dell’azienda, che dopo la riunificazione tedesca ritrova la struttura attuale; la competenza storica nella progettazione e nei materiali (Abbe, Schott) è la radice culturale da cui discende anche la diffusione moderna del concetto FLE.
Leica deriva dal percorso di Ernst Leitz, che assume la guida dell’Optisches Institut nel 1869 e porta alla nascita della Leica Camera AG; la letteratura aziendale recente ripercorre le “quattro generazioni Leitz” sino al riassetto degli anni Ottanta, con spostamento del baricentro industriale e ritorno a Wetzlar.
Minolta, fondata nel 1928, confluisce in Konica Minolta nel 2003 e nel 2006 abbandona il business fotografico cedendo parte delle attività reflex a Sony: una cronologia utile per contestualizzare il contributo Minolta all’autofocus e, per riflesso, alla generazione di obiettivi moderni con IF e cinematismi complessi.
Con queste pietre miliari fissate, è più semplice leggere il presente del floating in macro. Nel workflow reale, ciò che cambia per il fotografo è la possibilità di lavorare a rapporti elevati mantenendo uniformità di resa lungo il campo e riducendo la necessità di “chiudere sempre”, con relativo rischio di diffrazione su pixel piccoli. Il floating non cancella i vincoli fisici (l’apertura effettiva cala comunque all’aumentare dell’estensione, e la profondità di campo resta sottilissima), ma “distribuisce” meglio gli errori: un macro 100/105 moderno consente di scegliere f/8–f/11 “di progetto”, non “per necessità di soccorso”, perché sferica e campo sono già seguite meccanicamente dalla coreografia interna dei gruppi.
È utile ricordare, infine, tre corollari pratici. Primo, molti IF macro introducono accorciamento di focale: la distanza di lavoro può risultare più breve di quanto la focale nominale lasci immaginare, e la respiro in live‑view è il prezzo per l’ottimizzazione delle aberrazioni. Secondo, i macro moderni con floating sono più tolleranti ai diaframmi medi senza crolli di resa periferica, quindi focus stacking e bracketing beneficiano di file più omogenei. Terzo, l’abbinamento con coatings avanzati e vetri ED/UD completa il quadro, riducendo flare e frange in un regime di raggi molto inclinati tipico della macro spinta. Questi punti sono coerenti con le descrizioni ufficiali dei produttori e con la manualistica tecnica contemporanea.
Mi chiamo Alessandro Druilio e da oltre trent’anni mi occupo di storia della fotografia, una passione nata durante l’adolescenza e coltivata nel tempo con studio, collezionismo e ricerca. Ho sempre creduto che la fotografia non sia soltanto un mezzo tecnico, ma uno specchio profondo della cultura, della società e dell’immaginario di ogni epoca. Su storiadellafotografia.com condivido articoli, approfondimenti e curiosità per valorizzare il patrimonio fotografico e raccontare le storie, spesso dimenticate, di autori, macchine e correnti che hanno segnato questo affascinante linguaggio visivo.