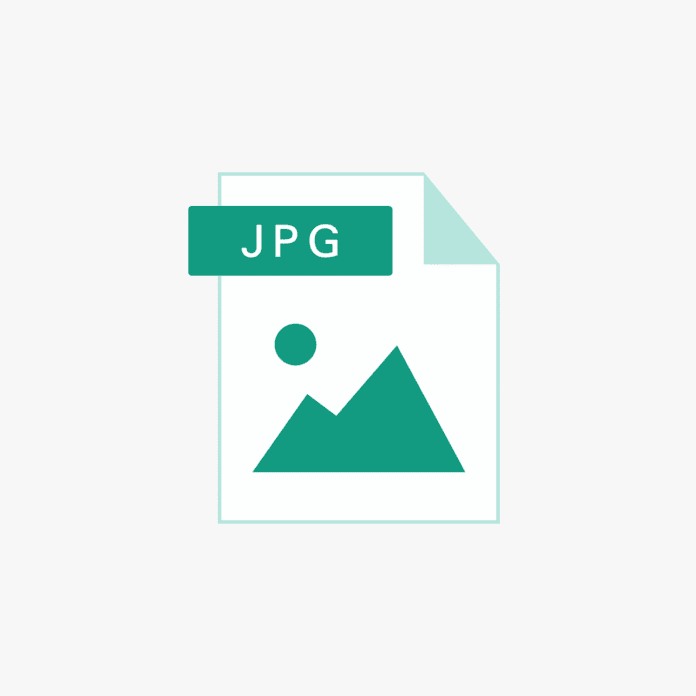Il concetto di formato d’immagine nasce dall’esigenza di definire come i dati visivi vengono organizzati e memorizzati. In fotografia analogica, il termine “formato” indicava la dimensione fisica del negativo o della pellicola: 35 mm, medio formato, grande formato. Con l’avvento del digitale, il significato si è spostato verso la struttura dei file che contengono le informazioni dell’immagine. Un formato digitale è un insieme di regole che stabiliscono come i pixel, la profondità di colore e i metadati vengono codificati e compressi.
La nascita dei formati digitali è strettamente legata allo sviluppo dei primi sistemi di elaborazione grafica negli anni ’70 e ’80. In questa fase pionieristica, i computer potevano gestire solo immagini a bassa risoluzione e con palette limitate. Il formato BMP (Bitmap), introdotto da Microsoft nel 1986, fu uno dei primi standard per rappresentare immagini raster, ossia composte da pixel. BMP memorizzava i dati senza compressione, garantendo fedeltà ma occupando molto spazio, un problema critico in un’epoca di capacità di memoria ridotte.
Con la diffusione della fotografia digitale negli anni ’90, la necessità di formati più efficienti divenne evidente. Le immagini catturate dai sensori CCD e CMOS dovevano essere archiviate in modo compatto senza perdere troppa qualità. Nacque così il JPEG (Joint Photographic Experts Group), standardizzato nel 1992, che introdusse la compressione lossy, riducendo drasticamente il peso dei file grazie alla rimozione di informazioni visive considerate non essenziali. Questo formato rivoluzionò la fotografia digitale, rendendo possibile la memorizzazione di centinaia di immagini su supporti relativamente piccoli.
Parallelamente, il concetto di profondità di colore divenne centrale. Ogni pixel è definito da un certo numero di bit che rappresentano le componenti cromatiche. Nei formati più semplici, come BMP, si partiva da 8 bit per pixel, mentre i formati moderni arrivano a 16 o 32 bit per canale, garantendo una gamma tonale molto più ampia. Questo aspetto è cruciale per la fotografia professionale, dove la fedeltà cromatica e la possibilità di intervenire in post-produzione richiedono dati ricchi e non compressi.
Un altro elemento fondamentale è la gestione dei metadati, introdotti con lo standard Exif (Exchangeable Image File Format) nel 1995. I metadati includono informazioni come data di scatto, impostazioni della fotocamera, coordinate GPS e profili colore. Questi dati sono integrati nel file immagine e sono indispensabili per il workflow digitale moderno.
Dal punto di vista storico, il concetto di formato d’immagine si è evoluto in parallelo con le esigenze del mercato: dalla semplicità dei primi bitmap alla complessità dei formati RAW, che memorizzano i dati grezzi del sensore senza elaborazione. Il RAW, introdotto dai produttori di fotocamere professionali alla fine degli anni ’90, ha trasformato il modo di lavorare dei fotografi, offrendo un controllo totale sul processo di sviluppo digitale.
Principali formati fotografici e loro caratteristiche tecniche
I formati d’immagine non sono tutti uguali: ciascuno risponde a esigenze specifiche, bilanciando qualità, peso e compatibilità. Il più diffuso è senza dubbio il JPEG, nato nel 1992 e ancora oggi standard universale per la fotografia consumer. JPEG utilizza una compressione lossy, basata sulla trasformata discreta del coseno (DCT), che riduce i dati eliminando dettagli impercettibili all’occhio umano. Il vantaggio è la leggerezza del file, ideale per archiviazione e condivisione. Il limite è la perdita di qualità, soprattutto dopo ripetute compressioni.
Per chi cerca massima fedeltà, il riferimento è il TIFF (Tagged Image File Format), introdotto nel 1986 da Aldus Corporation e adottato come standard per la stampa professionale. TIFF supporta compressione lossless e profondità colore fino a 16 bit per canale, garantendo immagini di altissima qualità. Tuttavia, il peso dei file è elevato, rendendolo poco pratico per archiviazioni massive.
Il RAW merita un capitolo a parte. Non è un formato unico, ma una famiglia di formati proprietari (CR2 per Canon, NEF per Nikon, ARW per Sony) che memorizzano i dati grezzi del sensore. Il vantaggio è la possibilità di intervenire su esposizione, bilanciamento del bianco e gamma tonale senza perdita di qualità. Il limite è la necessità di software dedicati e la scarsa compatibilità universale. Storicamente, il RAW è stato introdotto alla fine degli anni ’90 per rispondere alle esigenze dei fotografi professionisti, e oggi è lo standard per chi lavora in ambito editoriale e pubblicitario.
Il PNG (Portable Network Graphics), nato nel 1996 come alternativa libera al GIF, è molto usato nel web per la sua compressione lossless e il supporto alla trasparenza. Tuttavia, non è ideale per la fotografia ad alta risoluzione, poiché genera file pesanti.
Tra i formati più recenti spicca l’HEIF (High Efficiency Image File Format), introdotto nel 2015 e adottato da Apple per i dispositivi iOS. HEIF utilizza la compressione basata sul codec HEVC, garantendo qualità superiore a JPEG con dimensioni ridotte. Supporta profondità colore fino a 16 bit e funzioni avanzate come sequenze di immagini e metadati estesi. È considerato il futuro della fotografia consumer, anche se la compatibilità non è ancora universale.
Dal punto di vista tecnico, la scelta del formato dipende dal workflow: JPEG per la condivisione rapida, RAW per la post-produzione, TIFF per la stampa professionale, HEIF per chi cerca efficienza senza sacrificare qualità. Ogni formato è il risultato di compromessi tra qualità, peso e compatibilità, e la loro evoluzione riflette le trasformazioni della fotografia digitale negli ultimi trent’anni.
Compressione e algoritmi: come i formati gestiscono i dati
La compressione è il cuore del funzionamento dei formati d’immagine digitali. Senza di essa, i file sarebbero enormi e difficili da gestire, soprattutto considerando che una singola foto a risoluzione elevata può contenere milioni di pixel. Ogni pixel è definito da valori numerici che rappresentano le componenti cromatiche (RGB o altri spazi colore), e la quantità di dati cresce rapidamente con la profondità di colore. Per esempio, un’immagine da 24 megapixel con profondità di 24 bit per pixel occuperebbe oltre 70 MB senza compressione. Da qui nasce la necessità di algoritmi capaci di ridurre il peso dei file mantenendo una qualità accettabile.
Esistono due approcci principali: compressione lossless e compressione lossy. La prima conserva tutti i dati originali, garantendo che l’immagine possa essere ricostruita senza alcuna perdita. Formati come TIFF e PNG utilizzano questo metodo, basato su algoritmi come LZW (Lempel-Ziv-Welch) o Deflate. Questi algoritmi sfruttano ridondanze nei dati, come sequenze ripetute di pixel, per ridurre la dimensione del file senza alterare la qualità visiva. Il vantaggio è evidente: fedeltà assoluta. Il limite è che il guadagno in termini di spazio è modesto rispetto alla compressione lossy.
La compressione lossy, introdotta con il formato JPEG nel 1992, è basata su un principio diverso: eliminare informazioni considerate non essenziali per la percezione umana. JPEG utilizza la trasformata discreta del coseno (DCT) per suddividere l’immagine in blocchi di 8×8 pixel e rappresentare i dati in termini di frequenze spaziali. Le componenti ad alta frequenza, che corrispondono ai dettagli fini, vengono ridotte o eliminate, poiché l’occhio umano è meno sensibile a queste variazioni. Il risultato è una riduzione drastica del peso del file, con perdite di qualità che diventano evidenti solo a compressioni elevate.
Storicamente, l’adozione di JPEG fu determinante per la diffusione della fotografia digitale. Negli anni ’90, le schede di memoria avevano capacità limitate, e la possibilità di memorizzare centinaia di foto in formato compresso fu rivoluzionaria. Tuttavia, la compressione lossy introduce artefatti, come blocchi e aloni, soprattutto dopo ripetute ricompressioni. Per questo, i fotografi professionisti preferiscono formati lossless o RAW per la fase di editing.
Con l’evoluzione tecnologica, sono stati sviluppati algoritmi più sofisticati. Il formato HEIF, introdotto nel 2015, utilizza la compressione basata sul codec HEVC (High Efficiency Video Coding), che sfrutta tecniche di predizione inter-blocco e codifica entropica per ottenere file più leggeri a parità di qualità rispetto a JPEG. Analogamente, il formato AVIF, basato sul codec AV1, promette ulteriori miglioramenti, con una compressione più efficiente e supporto per profondità colore elevate.
Un concetto chiave è la quantizzazione, fase in cui i valori numerici vengono approssimati per ridurre la precisione e, di conseguenza, il peso del file. Nei formati lossy, la quantizzazione è il principale responsabile della perdita di qualità. Nei formati lossless, invece, si utilizzano tecniche di codifica statistica, come Huffman o aritmetica, per rappresentare i dati in modo più compatto senza alterarne il contenuto.
Dal punto di vista storico, la compressione è stata una risposta alle limitazioni hardware, ma oggi è anche una questione di efficienza energetica e velocità di trasmissione. I formati moderni devono bilanciare qualità, peso e compatibilità, tenendo conto delle esigenze di archiviazione, stampa e condivisione online. Questo spiega perché, nonostante l’esistenza di formati avanzati, JPEG rimane dominante: la sua universalità è un vantaggio che nessun algoritmo più recente ha ancora superato.
Evoluzione digitale e nuovi standard
L’evoluzione dei formati d’immagine è strettamente legata alla storia della fotografia digitale e alle trasformazioni tecnologiche degli ultimi trent’anni. Negli anni ’90, JPEG e TIFF erano i protagonisti indiscussi: il primo per la condivisione rapida, il secondo per la stampa professionale. Con l’avvento delle fotocamere digitali, i produttori introdussero i formati RAW, che memorizzano i dati grezzi del sensore senza elaborazione. Questo approccio rispondeva alle esigenze dei fotografi professionisti, offrendo un controllo totale sul processo di sviluppo digitale. Il RAW non è uno standard unico, ma una famiglia di formati proprietari (CR2 per Canon, NEF per Nikon, ARW per Sony), ciascuno con specifiche tecniche e algoritmi di compressione lossless o quasi-lossless.
Negli anni 2000, la diffusione di Internet e dei social network impose nuove priorità: ridurre il peso dei file per velocizzare il caricamento e la condivisione. JPEG rimase dominante, ma iniziò a mostrare i suoi limiti in termini di qualità e flessibilità. Nel 2010, il consorzio MPEG introdusse HEIF (High Efficiency Image File Format), basato sul codec HEVC. HEIF offre vantaggi significativi: compressione più efficiente, supporto per profondità colore fino a 16 bit, gestione di sequenze di immagini e metadati avanzati. Apple adottò HEIF nel 2017 per i dispositivi iOS, accelerandone la diffusione, anche se la compatibilità universale è ancora lontana.
Parallelamente, il formato AVIF, basato sul codec AV1, è emerso come alternativa open source, promettendo una compressione ancora più efficiente e una qualità superiore. AVIF supporta HDR, trasparenza e profondità colore elevate, caratteristiche che lo rendono ideale per applicazioni future. Tuttavia, la sua adozione è lenta, principalmente per motivi di compatibilità e potenza di calcolo richiesta.
Un altro candidato al futuro è JPEG XL, sviluppato per sostituire il JPEG tradizionale. JPEG XL offre compressione lossless e lossy, supporto per HDR e animazioni, e una retrocompatibilità pensata per facilitare la transizione. Nonostante le sue potenzialità, la sua diffusione è frenata dalla mancanza di supporto nativo nei principali browser e sistemi operativi.
Dal punto di vista storico, ogni nuovo formato nasce per rispondere a esigenze specifiche: efficienza, qualità, compatibilità. Tuttavia, la transizione è lenta perché l’ecosistema digitale è vasto e complesso. JPEG, nonostante i suoi limiti, rimane lo standard universale per la fotografia consumer, mentre RAW è imprescindibile per i professionisti. I formati emergenti come HEIF, AVIF e JPEG XL rappresentano il futuro, ma la loro affermazione dipenderà dalla capacità di garantire interoperabilità e facilità d’uso.
Oggi, la sfida non è solo tecnica, ma anche culturale: convincere milioni di utenti e migliaia di piattaforme ad adottare nuovi standard. Nel frattempo, la fotografia computazionale e l’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il concetto stesso di immagine, introducendo tecniche come il focus stacking, la ricostruzione HDR e la generazione sintetica. In questo contesto, i formati d’immagine dovranno evolversi per gestire non solo pixel, ma anche dati complessi come mappe di profondità e informazioni tridimensionali.
Fonti
- https://jpeg.org
- https://www.iso.org
- https://global.canon/en
- https://www.nikonusa.com
- https://www.adobe.com
- https://www.libpng.org
- https://aomedia.org
- https://jpeg.org/jpegxl
Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.