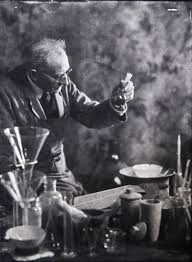Quando Théodore‑Henri Fresson, nato il 18 giugno 1865 a Enghien‑les‑Bains e morto il 15 luglio 1951 a Neuilly‑sur‑Seine, presentò alla Société française de photographie, nel 1899, delle “prove fotografiche su carta al carbone sviluppabili senza trasferimento”, si collocò in una linea di ricerca che, già nella seconda metà dell’Ottocento, aveva maturato una consapevolezza decisiva: l’immagine fotografica può essere fissata in modo estremamente stabile usando pigmenti colorati inglobati in un colloide fotosensibilizzato ai dicromati, in alternativa all’argento. Fu la sintesi di esperienze sulla gelatina dicromata che si rifacevano agli studi di Poitevin e all’ampio ventaglio dei procedimenti a pigmento; ma nel caso Fresson, l’innovazione risultò sostanziale perché permetteva lo sviluppo “diretto”, senza la classica operazione di trasferimento che caratterizzava il carbon transfer e che complicava la resa dei mezzitoni. Già attorno al 1900 i fogli commerciali Charbon‑Satin messi a punto dalla famiglia arrivarono sul mercato, con una reputazione legata al nero d’avorio e a un aspetto vellutato e opaco che i fotografi riconoscevano immediatamente, complice una fine reticolazione superficiale dall’impronta materica. L’atelier sottolineava la specificità del metodo: più strati sensibilizzati di diversa sensibilità, con quelli insolubilizzabili collocati verso il supporto cartaceo, così che, dopo esposizione, la gelatina indurita difendesse la stratigrafia durante il bagno di sviluppo, mentre la porzione solubile veniva fisicamente rimossa. La letteratura tecnica, che da sempre rimane parziale per via della riservatezza praticata dai Fresson, ha tramandato un particolare operativo emblematico: la rimozione del colloide non indurito con un impasto di segatura e acqua, dove l’azione meccanica finissima della segatura facilita il “depouillement” lasciando intatti i toni induriti dalla luce. Questa notazione, presente in più fonti divulgative e di identificazione storico‑tecnica, aiuta a comprendere perché il procedimento produca superfici poco rilievo ma granulosità leggibile, con un carattere “vellutato” e opaco distinto, spesso confuso (non senza errore) con collotipia o fotoincisione.
Per capire la differenza fra carbone diretto e carbone con trasferimento, conviene ricordare che nei sistemi ottocenteschi la tissue (gelatina pigmentata sensibilizzata ai dicromati) veniva esposta a contatto e poi trasferita su un secondo supporto prima dello sviluppo, così da portare lo strato solubile in cima e consentire la formazione dei mezzitoni; senza trasferimento, la porzione solubile finirebbe intrappolata sotto lo strato indurito e i mezzitoni collasserebbero in contrasti troppo severi. Vari tentativi di carbone “diretto” emergono già negli anni 1890: si cita spesso la carta Charbon‑Velours di Victor Artigue (1893), il cui sviluppo impiegava pure segatura; ma i risultati erano incostanti e, a detta delle fonti, solo il nero si dimostrò davvero utilizzabile. Fresson intervenne migliorando la chimica del colloide e la sequenza degli strati, mantenendo segreta la “ricetta” ma industrializzandone l’uso con la carta Charbon‑Satin in più tinte e supporti. Anche per questo, nelle guide di identificazione dei processi storici, il termine “Direct Carbon (Fresson)” è divenuto sinonimo di una famiglia di carte attive fra 1900 e seconda guerra mondiale, con caratteristiche diagnostiche ricorrenti: grana marcata, matte uniforme, reticolazione riconoscibile e scarso rilievo dell’immagine.
L’organizzazione produttiva agli albori conferma la dimensione al tempo stesso artigianale e semi‑industriale: la moglie di Théodore‑Henri, Maria, e i figli Pierre (n. 1904, m. 1983) ed Edmond (n. 1898, m. 1964) gestivano fabbricazione e vendita di fogli pronti all’uso; si parlava di diversi gradi cromatici, texture e grammature, con spedizioni per corrispondenza agli appassionati più esperti. L’eco del procedimento raggiunse gli ambienti pittorialisti: José Ortiz Echagüe, Léonard Misonne, Robert Demachy e Constant Puyo vengono spesso citati come autori che hanno sfruttato la particolare “pasta” tonale del carbone Fresson, portando alla ribalta quel vapore luminoso che, sul piano estetico, il procedimento tende a favorire nelle ombre vellutate e nei passaggi tonali compressi. Fin quando l’uso fu confinato al contatto, il formato risultava naturalmente limitato; ma quando l’atelier si indirizzò alle proiezioni per ingrandimento, la famiglia si dotò di un arco elettrico ad alto contenuto UV e di un ingranditore dedicato con ottica corretta per lo spettro ultravioletto, liberando esteticamente la procedura dai vincoli del contatto pur mantenendo la base chimico‑fisica del carbone diretto. Tale “svolta UV” segnò la maturità tecnica del metodo, restando però proprietaria nelle soluzioni esecutive, con assenza di brevetti e protezione del know‑how come scelta deliberata.
Nella storiografia dei procedimenti a colloide induribile ai dicromati – che include anche la gomma bicromatata – la posizione Fresson assume un ruolo peculiare. La gomma, il cui legante è gomma arabica anziché gelatina, permette controlli locali pittorici e multilayer ma richiede spesso molte mani di stesura e una calibrazione che ne ha sancito fama di processo capriccioso; il carbone con trasferimento è a sua volta tecnicamente esigente nella preparazione della tissue e del ricevente. Il carbone diretto Fresson si fa carico di questa complessità prima dello sviluppo – con una stratigrafia controllata “in fabbrica” – e la scarica al momento del depouillement, facendo leva su parametri come la granulometria della segatura, la temperatura dell’acqua, la composizione dei pigmenti e la viscosità della gelatina. Questa architettura spiega l’identità visiva delle stampe Fresson – il mat inconfondibile, la reticolazione, i neri non brillanti ma profondi, la lieve compressione dei mezzitoni – e la ragione della loro stabilità comparabile a quella del platino, conseguenza diretta dell’uso di pigmenti inerti anziché dye organici. Tali elementi, censiti nelle guide di identificazione e nelle sintesi storiche sui processi alternativi, collocano il metodo Fresson in una genealogia che valorizza permanenza e qualità tattile della superficie.
La prima stagione del processo – dalla presentazione del 1899 fino agli anni Trenta – si chiuse con una diffusione capillare in Europa e, fra 1927 e 1939, anche negli Stati Uniti tramite distributori dedicati; la seconda guerra mondiale interruppe la commercializzazione sistematica dei fogli e spinse l’atelier verso una trasformazione del modello: progressivo abbandono della vendita di carta e focalizzazione sull’esecuzione dei tiraggi su commissione. Non è un semplice dettaglio economico: è grazie a questa concentrazione che, nel dopoguerra, la storia del Fresson incontrerà la quadrichromia “senza trasferimento”, consolidando una nuova identità per la fotografia a pigmento a colori in un’epoca in cui il cromogeno dominava mercati e laboratori.
Dalla carta Charbon‑Satin alla Quadrichromia Fresson (1947–anni 1980)
Il passaggio dalla monocromia al colore nel contesto Fresson non fu una semplice estensione dello spettro, ma un nuovo impianto tecnico che dovette riscrivere la sequenza delle stratificazioni e l’ergonomia di laboratorio per uno sviluppo diretto ripetuto quattro volte sulla stessa carta. Dopo il 1947, con l’atelier che smette lentamente di vendere i fogli per dedicarsi ai tiraggi – Edmond per i contatti, Pierre per gli ingrandimenti – la famiglia intraprende la ricerca applicata al colore. Nel 1950 Pierre Fresson si sposta in un laboratorio a Savigny‑sur‑Orge, più vicino a Parigi, e coinvolge il figlio Michel (n. 1936, m. 2020) in una sperimentazione che, fra studi e prove, approderà ai primi tiraggi al carbone diretto a colori nel 1952 secondo una memoria di famiglia, e che sarà finalizzata in forma stabile alla fine degli anni Cinquanta (con il 1959 indicato in alcune cronologie tecniche come data di consolidamento operativo). A livello di principio, la Quadrichromia Fresson si fonda sulla sovrapposizione successiva di quattro emulsioni pigmentarie – ciano, giallo, magenta, nero – ciascuna sensibilizzata con dicromato, esposta per ingrandimento da negativi di separazione e sviluppata con acqua calda e segatura; tra uno strato e l’altro, la stampa viene risciacquata, asciugata, gelatinata e preparata alla mano successiva, fino all’eventuale vernice finale di gelatina chiara e all’indurimento/ lavaggio conclusivo per la stabilità. Il tutto senza alcun trasferimento, su un unico foglio, entro formati che l’atelier ha storicamente praticato fino a circa 60–62 × 80–92 cm, in relazione alla resa ottica dell’arco UV e alla tenuta meccanica del supporto.
La difficoltà del colore diretto sta proprio nella gestione della registrazione fra i quattro strati e nella tolleranza della gelatina pigmentata a ripetuti cicli coating–sensibilizzazione–esposizione–depouillement. La famiglia testimonia un tempo di lavorazione che per una singola immagine può occupare giorni o settimane, a seconda del formato, dell’umidità ambientale e della risposta pigmentaria; la stampa viene spesso ritoccata a mano, prima o dopo la vernice, nei limiti consentiti dalla stabilità del film colloidale. La combinazione di parametri – frazione pigmentaria, viscosità, tempo di esposizione UV, temperatura di sviluppo, inerzia del supporto – crea una firma estetica che gli storici e i conservatori riconoscono: opacità assoluta, colori saturi ma non lucidi, grana evidente con reticolazioni visibili in macro, un aspetto che molti avvicinano alle pastellature e che, al confronto con il cromogeno tradizionale, appare meno brillante ma più durevole alla luce. Non a caso, varie analisi storiche segnalano come, tra anni Settanta e Ottanta, artisti e autori abbiano scelto la quadrichromia Fresson per la stabilità rispetto ai dye‑coupler, già allora problematici in termini di fading e shift cromatico.
Sul piano operativo, l’atelier ha mantenuto l’uso di un arco elettrico ad alta emissione UV come sorgente costante, con un obiettivo corretto per l’ultravioletto a proiettare l’immagine dei negativi di separazione (ottenuti fotograficamente per analisi sottrattiva da un positivo o da un inversibile colore) direttamente sulla carta cartolina fotografica non baritata e a basso ritiro. L’indicazione di “cartolina” non va fraintesa: si tratta di un supporto pesante con scarsa tendenza al warping, condizione necessaria per tollerare i quattro cicli di bagnatura e asciugatura senza deformazioni che compromettere(bbero) la messa a registro cromatica. Per i monocromi – ancora oggi molto praticati – la procedura resta un unico ciclo pigmentario, di norma con nero d’avorio. L’atelier ne ha descritto a grandi linee l’operatività in pagine storiche e tecniche, evitando però qualsiasi dettaglio “critico” di ricetta (concentrazioni, additivi, condizioni di indurimento), così da proteggere l’ingrediente segreto che distingue il carbone diretto Fresson da qualsiasi clonazione amatoriale. Questa cultura del segreto – mai celata – si traduce in una riconoscibilità iconografica e tattile che, ancora negli anni Duemila, fa parlare di unico laboratorio al mondo capace di produrre stampe Fresson autentiche.
L’adozione da parte di fotografi di primo piano ha consolidato un canone visivo. Bernard Plossu – che lavora con i Fresson dal 1967 – indica nella mattezza e nel granulo la chiave di una discrezione tonale che mette a nudo il suo modo di guardare, lontano da effetti “strillati”; autori come Sheila Metzner hanno legato alcuni cicli iconici a questa tessitura vellutata e alla potenza emotiva che essa conferisce agli oggetti, ai tessuti, ai volti. Non si tratta di adesioni “feticistiche”, bensì di scelte coerenti con poetiche che rifuggono la brillantezza e la iper‑nitidezza come fini, cercando invece una materia cromatica che regga il confronto con i linguaggi della stampa d’arte. In parallelo, musei e archivi riconoscono al processo una permanenza stimata prossima al platino, qualità che, insieme alla singolarità di ogni tiraggio – inevitabilmente unico per micro‑variazioni di stesure ed esposizioni – ne ha favorito la presenza in collezioni istituzionali.
La storia d’impresa della famiglia, in questo arco cronologico, merita un inciso: se il fondatore Théodore‑Henri si era mosso come ingegnere agronomo in un’epoca in cui la curiosità scientifica coincidente con la pratica fotografica era prassi consueta, i figli Pierre ed Edmond trasformarono il laboratorio in una bottega di maestri‑stampatori, cessando gradualmente – dal 1947 – la vendita delle carte per focalizzare il servizio di tiratura per studi e artisti. Negli anni Cinquantasessanta la domanda di colore trovò nel procedimento Fresson una risposta di altissima qualità, soprattutto quando il mercato editoriale e pubblicitario chiese stampe stabili, di alta resa, in formati medio‑grandi. Il colore Fresson, completato e rodato tra 1952 e 1959, divenne così un linguaggio vero e proprio, con limiti produttivi evidenti – lentezza, costi, curva di apprendimento – ma con un valore estetico e conservativo che il sistema dell’arte e della fotografia d’autore cominciò a riconoscere come insostituibile.
Pratica attuale, conservazione e continuità familiare (anni 1990–oggi)
La bottega di Savigny‑sur‑Orge – stabilitasi lì dagli anni 1950 – ha attraversato il passaggio all’era digitale senza snaturarsi. La ragione sociale contemporanea Atelier Fresson risulta attiva e registrata all’indirizzo di Savigny‑sur‑Orge, con dati camerali francesi che, aggiornati a novembre 2022, vedono Jean‑François Fresson (n. 1960) quale presidente della società; la continuità è così non solo tecnica e familiare, ma anche giuridico‑organizzativa. Nel 2017, cronache locali descrivevano ancora Michel e Jean‑François al lavoro nell’atelier “annidato” nel tessuto residenziale della cittadina, a testimonianza di una trasmissione intergenerazionale che ha attraversato un secolo di tecnologie. La scomparsa di Michel nel 2020 ha consegnato a Jean‑François il ruolo di ultimo depositario di un sapere altamente tacito, oggetto di interviste e ritratto in film e articoli che mostrano l’ambiente di laboratorio e la ritualità dei gesti: bilance Roberval, cornici in legno, vasche di sviluppo, spandigelatina di fabbricazione “di casa”. La manualità non è romantizzazione: è parte costitutiva della qualità ottenibile, perché la tecnica richiede interventi puntuali over‑the‑process – spugne, velature, tocchi di colore – capaci di correggere sottigliezze altrimenti non gestibili con parametri standard.
Sul piano tecnico contemporaneo, gli elementi pubblicamente documentati confermano un impianto invariato: sorgenti UV continue (arco), ingrandimento da separazioni per la quadrichromia, e la medesima sequenza di coating/ esposizione/ sviluppo sullo stesso foglio. Le caratteristiche visive che ormai costituiscono la “firma” Fresson – mattezza assoluta, reticolazione più o meno pronunciata, grana fisica controllabile in fase di preparazione, neri non speculari ma pieni, cromie dal taglio vellutato – sono ben descritte dai repertori di riconoscimento dei processi e dai glossari dei musei, che ne riportano anche le criticità conservativo‑meccaniche (possibili abrasioni o fessurazioni degli strati in caso di condizioni ambientali sfavorevoli). È significativo come la stabilità alla luce venga spesso indicata quale vantaggio comparativo rispetto ai cromogeni: la chimica a pigmento rende le stampe intrinsecamente più durature, e questo spiega la presenza sistematica di Fresson in collezioni e archivi; analogamente, i manuali e le timeline dei processi color sottolineano che le Fresson Quadrichromie continuarono ad attrarre gli autori negli anni Settanta–Ottanta proprio per tale longevità. L’atelier dichiara formati massimi attorno a 60–62 × 80–92 cm, coerenti con la logica ottica e meccanica del processo.
Un paragrafo di metrologia visiva merita la questione del “grain” e della reticolazione: queste due firme non sono meri “difetti” estetici, ma la traccia tangibile della micro‑fisica del depouillement e della triangolazione fra pigmento, gelatina e supporto durante le fasi di reidratazione e solubilizzazione. La segatura usata nello sviluppo, per quanto fine, esercita un’azione abrasiva che, combinata con la gradiente di insolubilizzazione in profondità, produce isole di gelatina indurita che rispondono alla tensione superficiale dell’acqua calda con pattern reticolari. La scelta dei pigmenti – storicamente minerali o organici stabili – influenza la gamma e la saturazione più del gamut dei dye, ma porta anche una tessitura che, in macro, può ricordare micro‑puntinature di stampa d’arte. È questo tratto tattile a rendere riconoscibili molte stampe Fresson perfino in riproduzione digitale, dove la brillantezza è assente e la sostanza dell’immagine scaturisce da un assorbimento diffuso della luce nel film colloidale. Repertori museali e testi di storia dei processi fotografici non solo descrivono tali caratteristiche, ma forniscono comparazioni con collotipia e fotoincisione, che le Fresson possono ricordare per opacità e granulosità, pur rimanendo profondamente diverse nella struttura dell’immagine.
Dal punto di vista operativo‑professionale odierno, la produzione è minuziosa e limitata: si è parlato di ore di lavoro per singola stampa e di un numero annuo che resta contenuto, coerente con una logica bottegaia che preferisce pochi incarichi di livello piuttosto che volumi industriali. Questa scala ha favorito relazioni strette con fotografi di fama internazionale: Bernard Plossu continua a sottolineare come la mattezza del Fresson gli consenta di mettere bianco e nero e colore nello stesso respiro visivo; fashion e still‑life – si pensi a Sheila Metzner – hanno trovato nella Quadrichromia una materia cromatica capace di restituire il peso tattile dei materiali e degli oggetti. Accanto alla pratica artistica, la comunità degli storici della fotografia ha dedicato documentari e saggi al processo, presentando riprese d’officina che mostrano ingranditori storici, macchine per la stesura, e la lentezza programmatica dei cicli di asciugatura necessari tra uno strato e l’altro, due‑tre settimane per alcune lavorazioni a colori. Questi resoconti, pubblicati in sedi di divulgazione colta e di critica, rafforzano l’idea del Fresson come saper fare nel senso pieno del termine: una tecnica storica che sopravvive in virtù della continuità familiare e della ** domanda d’autore** per una fotografia pigmentaria irriducibile a imitazioni.
La conservazione pone sfide specifiche e vantaggi oggettivi. L’assenza di barite e la natura opaca riducono problematiche di specchiature e di abrasioni da contatto in condizioni espositive corrette; tuttavia, gli strati multipli di gelatina pigmentata restano sensibili a umidità relativa e stress meccanico, con rischio di fessurazioni in caso di oscillazioni ambientali. Linee guida di glossari e repertori museali suggeriscono intervalli climatici moderati e cornici con passpartout adeguati a limitare contatti. Sul piano della ricerca applicata, è interessante notare come nel mondo dei processi a dicromati si sia aperta da anni una riflessione su alternative meno tossiche (per esempio nella gomma con sistemi iron‑based tipo Chiba), segno che la conservazione della salubrità in laboratorio e la sostenibilità sono oggi parte dell’orizzonte culturale. Il Fresson storico resta però concettualmente legato alla triade gelatina–pigmento–dicromato, con l’atto meccanico della segatura quale gesto identitario.
Sullo sfondo, la storia d’impresa continua a scorrere. I registri societari mostrano l’attività dell’Atelier Fresson nella forma giuridica attuale, con recapito a Savigny‑sur‑Orge e presidenza a Jean‑François Fresson; l’atelier mantiene canali di contatto essenziali e una presentazione del processo che ribadisce più volte la proprietarietà di passaggi chiave. Questa continuità, unita alla qualità di autori che vi convergono, fa sì che, ancora oggi, quando si parla di Processo Fresson, non si evochi soltanto una tecnica ma una bottega viva, dove tempo, competenza e materia vengono orchestrati per dare vita a stampe cui il sistema dell’arte riconosce valore estetico e conservativo difficilmente eguagliabile.
Fonti e riferimenti
- Atelier Fresson – History & Technique.
https://www.atelier-fresson.com/history.htm | https://www.atelier-fresson.com/technique.htm | https://www.atelier-fresson.com/ (accesso generale). [Atelier Fresson], [Atelier Fresson], [Atelier Fr…dé fresson] - Graphics Atlas – Direct Carbon (Fresson) Identification/Overview.
http://graphicsatlas.org/identification/?process_id=306 | https://new.graphicsatlas.org/direct-carbon-fresson [Identifica…hics Atlas], [Direct Car…hics Atlas] - Pénichon, S. – Timeline of Historical Colors in Photography (Fresson Quadrichromy).
https://filmcolors.org/timeline-entry/39480/ [Fresson Qu…hy and …] - Procédé Fresson (voce enciclopedica).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_Fresson [Procédé Fr…Wikipédia] - Théodore‑Henri Fresson (biografia di base).
https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore-Henri_Fresson | https://www.wikidata.org/wiki/Q97357259 [Théodore-H…Wikipedia], [Théodore-H…- Wikidata] - Paris Photo – Glossary, Tirage Fresson.
https://www.parisphoto.com/en-gb/program/glossary/tirage-fresson.html [Tirage fre…sphoto.com] - The Printed Picture (Yale) – Non‑Silver Processes (contesto storico).
https://printedpicture.artgallery.yale.edu/the-book/non-silver-processes [Non-Silver…ed Picture] - AlternativePhotography – Breve storia del carbon printing / introduzione alla gomma.
https://www.alternativephotography.com/a-brief-history-of-carbon-printing/ | https://www.alternativephotography.com/an-introduction-to-the-gum-bichromate-process/ [A Brief Hi…graphy.com], [An introdu…te process] - Le Parisien – Savigny‑sur‑Orge, reportage sull’atelier (2017).
https://www.leparisien.fr/essonne-91/savigny-sur-orge-l-atelier-fresson-perpetue-un-savoir-faire-centenaire-05-07-2017-7112607.php [Savigny-su…-faire …] - Mairie de Paris / ARCP – Glossary (stabilità e aspetto).
https://www.parisphoto.com/en-gb/program/glossary/tirage-fresson.html [Tirage fre…sphoto.com] - Musée Magazine – “Fresson Printing Process” (feature).
https://museemagazine.com/features/2019/9/17/fresson-printing-process [Fresson Pr…e Magazine] - The Darkroom Rumour – saggio storico e intervista su Fresson / Plossu.
https://www.thedarkroomrumour.com/en/article/the-fresson-process-prints-by-andre-rouille | https://www.thedarkroomrumour.com/en/article/the-printing-in-photography-an-interview-with-bernard-plossu | Scheda Jean‑François Fresson: https://www.thedarkroomrumour.com/en/who/jean-francois-fresson [The Fresso…oom Rumour], [The Printi…ard Plossu], [Jean-Franç…- The …] - Atelier Fresson – pagina Home (contatti e continuità).
https://www.atelier-fresson.com/home.htm [Atelier Fresson] - Registri d’impresa (Francia) – Atelier Fresson.
https://www.pappers.fr/entreprise/atelier-fresson-349002709 | https://entreprises.lefigaro.fr/atelier-fresson-91/entreprise-349002709 [Société AT…- Pappers], [Atelier Fr…adresse…]
Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.