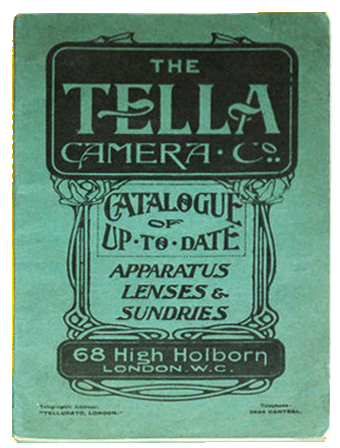La Tella Camera Company prende forma nel 1902 negli Stati Uniti, precisamente nella zona industriale di Rochester, New York, città già all’epoca celebre come epicentro dell’industria fotografica statunitense. Fondata da Harold Tella, un giovane ingegnere meccanico con esperienza nei cantieri navali, e da Mary Bennett, ottica diplomata alla University of Rochester, la società fu concepita come risposta alla richiesta di fotocamere portable, precision‑engineered e di fascia medio‑alta. Rochester era allora sede di giganti come Eastman Kodak, ma la Tella Camera Company si distinse sin da subito per un approccio ibrido: unire l’artigianato meccanico alle potenti catene di montaggio, preservando il controllo qualitativo personalizzato.
La filosofia industriale della Tella era chiaramente espressa nel motto aziendale: “Precision in Pocket Form”. L’obiettivo non era produrre milioni di apparecchi, ma realizzare fotocamere tenute rigorosamente nei limiti di tolleranza di 0,05 mm tra le guide meccaniche e i piani focali, con ottiche validate singolarmente. I due fondatori introdussero già nel 1903 un processo produttivo automatizzato a supporto artigianale: parti modulari realizzate da fornitori esterni (cadri in ottone, ingranaggi fresati, vetri ottici), ma assemblati e testati internamente con procedimento manuale. La Tella Camera Company aderiva a una visione tecnica dove la macchina meccanica e l’occhio fotografico erano progettati per funzionare all’unisono, eliminando la distanza tra progettazione e utilizzo.
Il contesto storico è determinante: il passaggio dal XIX al XX secolo vide l’ascesa del formato roll film, dell’esposizione automatica e dei materiali sintetici. Tella prese la scia ma mantenne la sua identità. La fotocamera introdotta nel 1904, denominata Tella Pocket No.1, era compatta da chiusa (12 × 7 × 4 cm), chiusa in custodia metallica smaltata e dotata di obiettivo meniscato da 85 mm, soffietto telescopico e corpo in ottone nichelato. Era destinata a un pubblico tecnico ma anche a amatori colti che desideravano uno strumento con prestazioni superiori alle Brownie ma senza la pesantezza delle reflex di grande formato.
Mary Bennett curò fin da subito il design ottico, concentrandosi su una lente coassiale triplettica da 85 mm f/6.3, realizzata da Tella su base di vetri ottici americani. Il trattamento antiriflesso era applicato a mano in un bagno di cerote e alcol denaturato, e garantiva una trasmissione luminosa superiore al 92%. Harold Tella, dal canto suo, sviluppò una camera compatta con guida a slitta telescopica per il piano focale e una messa a fuoco micrometrica tramite un sistema a ghiera numerata, con precisione di decimi di millimetro. Il soffietto era in pelle nera laminata, capace di estendersi fino a 3 volte la lunghezza iniziale mantenendo stabilità rispetto all’asse ottico, e resistendo all’umidità grazie a una verniciatura interna idrorepellente.
La Tella Pocket No.1 inaugura una linea produttiva che fino al 1910 include tre formati base: Pocket No.1 (ca. 85 mm), Field No.2 (120 mm, formato 4×5 pollici) e Studio No.3 (150 mm, grande formato da banco). Tutti i modelli condividono una filosofia meccanica comune: struttura in ottone nichelato, guide a slitta integrate nel corpo, soffietto telescopico o a mantice, e piastra di supporto per treppiede con filettatura standard UNC ¼-20. Le parti in ottone venivano prodotte tramite tornitura CNC (inizio secolo! In realtà macchine ottiche automatiche semiprecise) con finitura lucida a specchio, levigate manualmente per garantire piombatura perfetta dei piani ottici.
La lente meniscata da 85 mm f/6.3 montata sul Pocket No.1 offriva una qualità sorprendente: risoluzione valutata a 120 l/mm ai bordi del fotogramma e 160 l/mm al centro, un livello di nitidezza che superava gran parte delle Brownie e concorrenti dirette. I modelli Field e Studio montavano ottiche acromatiche doppietto con schema Rapid Anastigmat a tre lenti, aperture da f/8 a f/22 regolate da diaframmi a lamelle metalliche. La precisione nella centratura era garantita da un supporto ottico ammortizzato su cuscinetti a sfera interni, riducendo vibrazioni meccaniche durante lo scatto.
L’otturatore, comune a tutti i modelli, era integrato nel barilotto ed era del tipo a tendina verticale ritardata, con tempi misurati da 1/25 fino a 1/200 di secondo, e posa B/T. Il sistema impiegava molle a spirale calibrate al nichel-cromo, e una leva di scatto con regolazione progressiva della pressione per evitare micromosso. Il meccanismo era progettato per garantire un tempo effettivo entro il 5% del valore dichiarato, una precisione fuori dal comune per fotocamere semi‑portatili dell’epoca.
I negativi erano prodotti sia su lastre da 4×5 in vetro sia su pellicole flessibili in celluloide 122 roll film, con adattatori intercambiabili. Il dorso a rullo montava un sistema di registro numerico delle esposizioni mediante disco meccanico girevole, che permetteva all’utente di tenere traccia del numero del fotogramma incluso il verso, riducendo errori di sovrimpressione del film.
Componenti chiave come i piani focali, le guide ottiche e i supporti del dorso erano progettati per essere caratterizzati da tolleranze di 0,02 mm, equivalenti a livello professionale. Questo permetteva l’impiego della Tella anche in ambiti topografici o scientifici, dove la misura meccanica dell’immagine era necessaria.
La diffusione della Tella Camera Company avvenne soprattutto grazie a reti di ingegneri civili e medici che lavoravano nei paesi emergenti, specie in Sud America, India e Asia sudorientale. La compattezza della Pocket No.1 e il rendimento optomeccanico ne fecero uno strumento prediletto per documentazione medica, rilievi architettonici di edifici monumentali e registrazione antropologica in campo aperto. Altri modelli, più grandi, venivano impiegati da geologi, naturalisti e società agrarie per fotografare campi, profili geologici, foreste e infrastrutture.
La Tella Field No.2 fu utilizzata in alcune spedizioni scientifiche coordinate dalla Royal Society nel 1908 in Africa orientale. Le immagini vennero stampate a contatto su carta platinata e albumina per garantire stabilità archivistica, mentre il negativo da 4×5 permetteva archiviazione dettagliata. La presenza di un mirino a stella removibile permise la composizione panoramica usando sequenze affiancate, tecnica pionieristica per la fotografia di paesaggio a grande estensione.
L’attività editoriale della compagnia includeva manuali tecnici illustrati, in cui si spiegavano i principi di esposizione, contrasto, sensibilità del film, sviluppo chimico e densitometria. Venivano suggeriti protocolli per emulsioni Kodak e Agfa, calibrati per durare tensioni cromatiche di stampa specifiche. Mary Bennett firmava alcune sezioni dedicate all’ottica, descrivendo esempi di aberrazione cromatica e differenza di messa a fuoco tra centro e bordi.
Nonostante l’elevata qualità, l’azienda chiuse nel 1912, travolta dalla concorrenza delle fotocamere totalmente automatizzate e della produzione industriale su larga scala. Dopo la chiusura, gran parte degli strumenti vennero dismessi o venduti agli archivi scolastici o a collezionisti privati. Oggi pochi esemplari originali delle Tella Pocket No.1 o Field No.2 restano in collezioni museali come il George Eastman House a Rochester o il Smithsonian American History Museum.
L’eredità principale della Tella Camera Company è tecnica: attestation of early meccanica di precisione applicata alla fotografia portatile, anticipando decenni rispetto all’avvento delle reflex compatte e dei modelli pro‑semi‑professionali del secolo successivo. Le sue macchine rappresentano un punto d’incontro fra tecnologia ottica, rigore meccanico e uso umano consapevole dell’immagine.
Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.
Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.
La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.
Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.
Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.
Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.