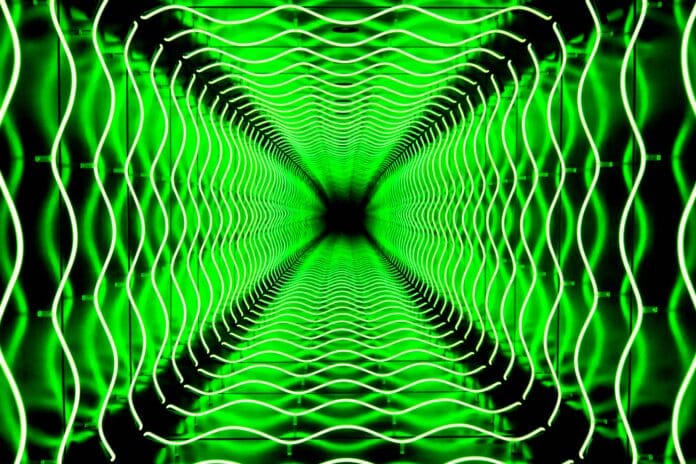Il concetto di fotografia transmediale nasce dalla necessità di superare i limiti statici della cornice bidimensionale, esplorando nuovi rapporti tra immagine, spazio e spettatore. Nei primi decenni del XX secolo la fotografia si affermò come mezzo autonomo, soprattutto grazie alle sperimentazioni di Moholy‐Nagy e della Bauhaus, che videro nell’associazione di fotografia e tipografia un primo passo verso la sincronizzazione tra linguaggi. Con l’avvento del video e poi del digitale, l’ibridazione tra fotografia e altri media si è intensificata: negli anni Novanta, la pratica del «photomontage digitale» inaugurò un’epoca in cui l’immagine fotografica poteva convivere con elementi sonori su CD‐ROM interattivi, mentre i primi progetti di realtà virtuale panoramica utilizzavano la fotogrammetria per ricostruire ambienti in 3D.
Oggi la fotografia non è più confinata in una singola superficie: grazie all’Extended Reality (XR) — termine ombrello che include realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e realtà mista (MR) — l’immagine fotografica diventa parte di un ambiente immersivo e interattivo. La fotocamera tradizionale viene affiancata da scanner LiDAR, poliedrici sistemi di lidar mapping e tecnologie di depth sensing che consentono di raccogliere non solo pixel RGB, ma dati di profondità, coordinate 3D e texture ambientali. Questi dataset, elaborati con software di point cloud processing come Agisoft Metashape o RealityCapture, permettono di creare gemelli digitali di interni, monumenti o paesaggi, pronti per essere fruiti in visori VR o integrati in applicazioni AR su smartphone e tablet.
Il passaggio dalla narrazione lineare dell’immagine isolata alla creazione di experience design coinvolge un complesso flusso di lavoro: cattura multipla (multi‐view photography), allineamento delle immagini, ottimizzazione del mesh, texturing e export in formati compatibili con motori real‐time come Unity o Unreal Engine. Questo processo richiede competenze che uniscono la tradizionale tecnica fotografica — calibratura del bianco, gestione dei profili colore, controllo dell’esposizione e dell’illuminazione HDR — a nozioni di grafica digitale e programmazione, per garantire che il risultato finale sia non solo visivamente coerente, ma anche performante su hardware consumer.
La MIA Photo Fair 2025, da sempre attenta alle contaminazioni tra fotografia e nuove forme espressive, dedica quest’anno una sezione intitolata “Dialogo” proprio alla fotografia transmediale. Gli artisti invitati mostrano come l’immagine possa espandersi in forme diverse: installazioni in cui fotografie panoramiche a 360° scorrono su schermi curvi, stand‐alone AR che richiamano inquadrature stampate su carta, e progetti VR in cui lo spettatore si muove tra scatti tridimensionali. Questo dialogo tra fotografia e discipline come sound design, performance art, videomapping e architettura dimostra che il medium fotografico è oggi un terreno di sperimentazione aperto, in cui reale e virtuale si intrecciano, restituendo all’immagine uno spazio di azione e interazione inedito.
Tecnologie XR e immersive storytelling
La realtà virtuale (VR) porta la fotografia in uno spazio completamente generato dal computer, dove l’utente indossa un visore e si immerge in ambienti ricostruiti tramite fotogrammetria o rendering 360. I flussi di lavoro VR coinvolgono il recupero di immagini sferiche ad alta risoluzione, spesso acquisite con sistemi multi‐lens (come il rig Ladybug5 o fotocamere 360° di fascia prosumer), e la loro unione in una texture panoramica che copre integralmente una sfera delimitata dalle coordinate yaw‐pitch. L’HDR stitching assicura che le alte luci e le ombre mantengano dettaglio, ottenendo mappe tonali compatibili con motori PBR (Physically Based Rendering).
Parallelamente, nella realtà aumentata (AR), la fotografia transmediale sfrutta marker‐based e marker‐less tracking per sovrapporre contenuti fotografici in ambienti reali. App su piattaforma ARKit (iOS) o ARCore (Android) permettono di riconoscere superfici piane o immagini di riferimento (photo‐targets), ancorando illustrazioni, animazioni o scatti tridimensionali nello spazio visibile attraverso lo schermo. Questa tecnica apre a soluzioni editoriali dove la pagina di un catalogo stampato diventa portale per scoprire scatti aggiuntivi, video immersivi o schede tecniche in overlay.
La realtà mista (MR) combina gli elementi di AR e VR in esperienze ibride: visori come il Microsoft HoloLens o il Magic Leap One consentono di proiettare fotografie digitali in un ambiente reale, lavorando con ologrammi che possono essere spostati, ridimensionati e animati. Questi dispositivi integrano sensori ToF (Time of Flight), IMU (Inertial Measurement Unit) e videocamere frontali per mapping in tempo reale, abilitando progetti in cui lo spettatore interagisce fisicamente con le immagini, ad esempio sfogliando scatti sospesi nell’aria o attivando sequenze fotografiche tramite gesture.
Il rendering real‐time è al cuore di queste applicazioni. Motori grafici come Unity e Unreal Engine gestiscono milioni di poligoni, calcolano luci globali tramite tecniche di light baking e ray tracing, e supportano shading avanzati. La progettazione di un’esposizione fotografica virtuale comporta la definizione di coordinate UV per la texturizzazione, l’ottimizzazione LOD (Level of Detail) per mantenere frame rate elevati e l’uso di occlusion culling per ridurre il carico computazionale. I file finali vengono esportati in formati standard (glTF, USDZ, FBX) per garantire interoperabilità tra dispositivi e piattaforme.
Queste tecnologie non richiedono più hardware di nicchia: visori standalone come Oculus Quest 3 o Pico 4, cuffie AR mobili e smartphone di fascia alta offrono performance tali da poter fruire di esperienze transmediali con budget contenuti. Ciò democratizza l’accesso a un panorama finora riservato a laboratori specializzati, trasformando ogni smartphone in un potenziale gateway verso mondi fotografici estesi.
Installazioni interattive e spatial design
La fotografia transmediale non è solo fruizione singola, ma spesso si traduce in installazioni site‐specific che coinvolgono lo spettatore come attore. Gallerie e spazi museali si trasformano in ambienti dinamici grazie a proiettori a corta distanza, schermi LED voxel, e sistemi di motion tracking. Attraverso sensori Kinect o telecamere infrarossi, ogni movimento dell’utente può modificare la visualizzazione delle fotografie: un gesto attiva sequenze di scatti, un passo modifica l’angolo di visione, un suono innesca transizioni cromatiche.
Il sound design diventa compagno indispensabile: altoparlanti direzionali e sistemi beamforming creano colonne sonore localizzate, che dialogano con le immagini. In un’installazione transmediale, la fotografia smette di essere un oggetto passivo e acquisisce uno spazio tridimensionale dove il ritmo sonoro e il timing visivo si intrecciano, generando un’esperienza multisensoriale. La sincronizzazione tra fotogrammi e tracce audio richiede l’uso di software di live media server come TouchDesigner o Isadora, capaci di gestire MIDI, OSC e DMX per un controllo in tempo reale di video mapping, luci e audio.
Il projection mapping offre un ulteriore livello di complessità: fotografie 2D vengono proiettate su architetture, oggetti o superfici non convenzionali, seguendo mesh di deformazione che adattano l’immagine alle geometrie fisiche. Attraverso software come MadMapper, le texture fotografiche vengono agganciate a modelli 3D di edifici o sculture, rendendo possibile la “ricucitura” tra fotografia e spazio reale. Questa tecnica è utilizzata in festival internazionali, spazi urbani e fiere come MIA Photo Fair, dove i visitatori possono assistere a installazioni che plasmano fotografie su colonne, pareti curve o supporti trasparenti, giocando con la percezione di profondità.
Le interfacce utente per queste installazioni variano da touchscreen multitouch a pedane sensibili alla pressione, da glove controllers a semplici dispositivi gestuali. Il layout spaziale viene progettato in collaborazione con architetti e sound engineers, per garantire coerenza tra flusso di visitatori e percorso narrativo. Ogni elemento, dalla posizione delle casse audio alla luminosità dei proiettori, è calibrato in Lux per mantenere leggibilità fotografica senza compromettere l’atmosfera immersiva.
Il risultato è un ambiente in cui la fotografia non viene solo mostrata, ma vissuta: il pubblico non è più spettatore passivo ma co‐autore dell’esperienza, influenzando con la propria presenza la sequenza, l’intensità e la durata delle immagini. Queste pratiche affermano che la fotografia transmediale è un medium plastico, capace di adattarsi e trasformarsi in risposta alla partecipazione del fruitore.
Fotogrammetria avanzata e realtà mista
La fotogrammetria è tecnica chiave per la fotografia transmediale: permette di generare mesh tridimensionali dettagliate a partire da centinaia di scatti sovrapposti. BTSync tra le immagini avviene tramite algoritmi SIFT e SURF, che individuano punti caratteristici per allineare le foto in uno spazio 3D. Software dedicati calcolano Millions of Tie Points e creano la nuvola di punti, successivamente sostituita da una mesh poligonale con retopologia automatica. Il texturing finale applica mappe diffuse, normal map e occlusion map per ottenere superfici realistiche.
Nella realtà mista, le mesh fotogrammetriche vengono integrate in ambienti reali attraverso visori HMD che supportano occlusione tra oggetti virtuali e reali. Gli SDK MR gestiscono l’anchor placement, sincronizzando coordinate della mesh con l’ambiente georeferenziato. Gli sviluppatori utilizzano ARFoundation o Unreal XR Toolkit per creare scene ibride in cui l’utente vede sovrapposti elementi fotografici in 3D dotati di colliders e fisiche semplificate, consentendo interazioni naturali come spostamento, rotazione e trigger di animazioni.
Queste tecniche sono impiegate non solo in ambito artistico, ma anche in contesti di heritage preservation, dove siti archeologici vengono documentati con fotogrammetria e poi ricostruiti in AR per visite virtuali. I progetti transmediali di MIA Photo Fair includono esposizioni in cui il pubblico, attraverso tablet o visori, esplora ricostruzioni 3D di antichi edifici fotografati in situ, muovendosi liberamente e attivando contenuti informativi legati a ciascun punto di interesse.
Performance live e fotografia generata
La fotografia transmediale incontra la performance art in eventi live dove gli scatti vengono proiettati e manipolati in tempo reale. Fotografi‐DJ, dotati di macchine mirrorless collegate a laptop, scattano immagini che, grazie a plugin personalizzati in Max/MSP o Pure Data, vengono convertite in stream video e sottoposte a filtri visuali. Correzioni di bilanciamento colore, effetti glitch e trasformazioni generative si attivano al ritmo della musica, creando veri e propri VJ set fotografici.
Questo approccio richiede una pipeline a bassa latenza: la fotocamera invia RAW via tethering al software di elaborazione, che utilizza GPU CUDA per applicare LUT e filtri FFT‐based, restituendo l’immagine in formato video su un media server. L’uso di protocolli SMPTE e timecode consente di sincronizzare la musica e le luci con gli scatti, garantendo un’esperienza coerente tra visivo, sonoro e spaziale. Queste performance transmediali evidenziano come la fotografia possa assumere un ruolo da protagonista in spettacoli multimediali, aprendosi a un pubblico più ampio e interdisciplinare.
Piattaforme digitali e “Dialogo” a MIA Photo Fair 2025
La MIA Photo Fair 2025 ha istituito una sezione “Dialogo” dedicata ai progetti transmediali, con speaker internazionali e workshop hands‐on. Piattaforme come Photolio XR e ArtSteps consentono di creare gallerie virtuali dove le fotografie, in un contesto tridimensionale, sono esposte come opere sospese. Gli utenti navigano con avatar personalizzati e interagiscono con metatag AR, potendo acquistare stampe limitate tramite smart contract blockchain che garantiscono autenticità e provenienza.
La sezione prevede talk su protocolli open source per l’integrazione di immagini 360 in web browser (WebXR), esempi di storytelling interattivo con Twine e Unity WebGL, e dimostrazioni di app mobile che trasformano fotografie in ologrammi tramite dispositivi come Looking Glass Portrait. In questo spazio, fotografi, curatori e sviluppatori dialogano per definire linee guida etiche e tecniche, lavorando su formati standardizzati di metadata estesi (XMP‐XR) per descrivere coordinate spaziali, properties di interazione e dati di rete.
Questo dialogo interdisciplinare sancisce la fotografia transmediale come linguaggio in divenire, capace di adattarsi alle evoluzioni della tecnologia e di ampliare il proprio spettro espressivo. Le esperienze presentate a MIA Photo Fair mostrano che l’immagine non è un dato fisso, ma un flusso dinamico che può essere manipolato, esplorato e vissuto in molteplici dimensioni.
Manualità digitale e nuove competenze
La transmedialità fotografica richiede un mix di competenze: dalla gestione ottica tradizionale, con otturatori globali o rolling shutter calibration, all’uso di scripting in C# o Python per automatizzare flussi di export 3D. L’approccio artigianale si fonde con pratiche di coding: la creazione di plugin per motori grafici, l’ottimizzazione di shader HLSL/GLSL e la conoscenza di protocolli di rete per streaming su WebRTC. La cura nei dettagli — profilatura colore, validazione di mesh, retopologia manuale e baking di mappe normal — convive con la rapidità richiesta dalla prototipazione rapida di experience.
La fotografia transmediale rappresenta dunque un paradigma di ibridazione tecnica e artistica, in cui il fotografo contemporaneo diventa produttore di contenuti interattivi, capace di dialogare con designer, developer, sound engineer e curatori. Questo approccio apre prospettive non solo culturali, ma anche professionali, ridefinendo i confini di una disciplina che non è mai stata così fluida ed espansiva.
Mi chiamo Giorgio Andreoli, ho 55 anni e da sempre affianco alla mia carriera da manager una profonda passione per la fotografia. Scattare immagini è per me molto più di un hobby: è un modo per osservare il mondo con occhi diversi, per cogliere dettagli che spesso sfuggono nella frenesia quotidiana. Amo la fotografia analogica tanto quanto quella digitale, e nel corso degli anni ho accumulato esperienza sia sul campo sia nello studio della storia della fotografia, delle sue tecniche e dei suoi protagonisti. Su storiadellafotografia.com condivido riflessioni, analisi e racconti che nascono dal connubio tra approccio pratico e visione storica, con l’intento di avvicinare lettori curiosi e appassionati a questo straordinario linguaggio visivo.