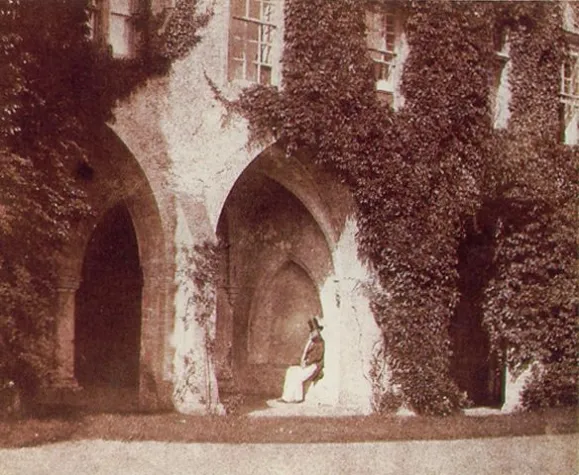Quando nel 1889 il chimico scozzese W. W. J. Nicol (n. 1855, m. 1929) depositò il suo brevetto per un procedimento di stampa fotografica ferro‑argento “a sviluppo”, la Callitipia si inserì in un panorama in rapida trasformazione, segnato dall’ascesa delle carte argentiche industriali e dal prestigio estetico della platinotipia. L’idea di Nicol, formalizzata con ulteriori revisioni nei primi anni Novanta dell’Ottocento, puntava a sfruttare l’ossalato ferrico come elemento fotosensibile e il nitrato d’argento come precursore dell’immagine metallica, separando nettamente il momento dell’esposizione da quello dello sviluppo riducente. In questo, la Callitipia differiva sia dai processi printing‑out come Van Dyke e Argirotipia (che formano l’immagine durante l’esposizione) sia dai procedimenti a nobile (platino/palladio), con cui tuttavia condivideva il medesimo sensibilizzante ferrico ossalato. La data del 1889 e la paternità a Nicol sono riportate in modo consistente nella manualistica storica e contemporanea, che ricorda anche la traiettoria evolutiva del metodo: dalle prime formule con sviluppo in nitrato d’argento in soluzione, alla scelta – oggi standard – di incorporare l’argento direttamente nel sensibilizzatore, lasciando al bagno di sviluppo il compito di far precipitare l’immagine in argento metallico con la finezza tonale che lo contraddistingue.
Per comprendere la Callitipia nella genealogia delle antiche tecniche, bisogna risalire al 1842, quando John F. W. Herschel descrisse per la prima volta il comportamento fotochimico dei sali ferrici in presenza di luce, gettando le basi teoriche per i processi ferro‑argento e per la più tarda famiglia platino/palladio. Se Van Dyke e Argirotipia si basano su ferrico ammonio citrato e reagiscono direttamente in esposizione, la Callitipia sostituisce questo ingrediente con ferrico ossalato, ottenendo da un lato una maggiore profondità dei neri (DMAX), dall’altro un più ampio controllo del contrasto grazie alla cinematica “develop‑out”. Queste differenze, spiegate da chi ha codificato la prassi moderna della tecnica, hanno dato alla Callitipia una fisionomia precisa: una stampa a contatto destinata a negativi in grande formato o internegativi di pari dimensioni, modulabile nel tono tramite la scelta del developer e successivi viraggi con oro, platino o palladio. Nei manuali si legge che proprio la flessibilità del sistema ferro‑ossalato consente di stampare negativi con ampie escursioni densitometriche, cosa che i processi “printing‑out” gestiscono con maggiori difficoltà.
La storia della ricezione del procedimento è ricca di contraddizioni. In piena “età della carta al gelatinobromuro”, la Callitipia faticò a imporsi sul piano commerciale: le gaslight papers e, a seguire, le carte DOP argentiche offrirono workflow rapidi, luci di esposizione modeste e un’ergonomia facilmente scalabile nei laboratori di ritratto. Eppure la Callitipia fu considerata, già all’epoca, la “platinotipia dei poveri”: quando virata in platino/palladio, la sua impronta estetica e la struttura metallurgica dell’immagine risultano quasi indistinguibili da una vera stampa al platino, al punto che la letteratura tecnica ricorda casi di attribuzioni errate in cui Callitipie virate furono vendute o catalogate come platinotipie. L’affermazione riposa su due osservazioni convergenti: la parentela chimica con i processi a nobile – stesso sensibilizzante ferrico – e le analisi comparative condotte da storici e stampatori, che riportano identità visive difficili da sciogliere senza ricorrere a metodi analitici strumentali.
Se la qualità non era in discussione, la permanenza suscitò, invece, diffidenza. Nelle prime ricette si raccomandavano fissaggi oggi considerati inadeguati (come bagni ammoniacali), e le prassi di chiarifica per rimuovere il ferro residuo non erano ancora consolidate; così alcune Callitipie storiche soffrirono di ingiallimenti nelle alte luci, alimentando la narrazione di un processo instabile. La manualistica moderna ha ribaltato questo giudizio: una Callitipia ben chiarita, virata con metalli nobili e fissata in tiosolfato risulta archivisticamente affidabile, e i viraggi in oro/Pt/Pd incrementano la resistenza a ossidazione e solforazione, allineando la stabilità a quella dei processi di riferimento per la conservazione. In questo senso, la “cattiva fama” ottocentesca appare oggi più un effetto di cattive pratiche che un limite intrinseco del procedimento.
Sotto il profilo del lessico, in Italia la voce Callitipia è stata talvolta usata in modo estensivo per indicare la stampa bruna o lo stesso Van Dyke. Per una lettura storica coerente conviene, però, mantenere la distinzione classica: Kallitype/Callitipia come processo ferro‑ossalato “develop‑out” con developer dedicato; Van Dyke come processo ferro‑citrato “printing‑out” a immagine che matura in esposizione; Argirotipia come variante moderna del printing‑out con argento sulfammato; tre rami della medesima famiglia ferro‑argento, ma con ergonomie e risposte tonali differenti. Questa chiarezza aiuta sia la catalogazione sia la diagnosi conservativa, perché i protocolli di chiarifica e fissaggio più efficaci non sono identici per tutte le varianti.
Dal punto di vista delle date e dei protagonisti, l’ordine è chiaro: nel 1842 Herschel propone lo scheletro teorico; tra 1889 e 1891 Nicol mette a punto e brevetta la Callitipia in più varianti; negli anni 1890 si consolidano anche le ricette Van Dyke; nel corso del Novecento la Callitipia lascia il palcoscenico commerciale alle carte argentiche, sopravvivendo però in ambienti sperimentali e nelle accademie. Il suo ritorno all’inizio del XXI secolo, complice la curva digitale per produrre internegativi calibrati, si spiega con i costi inferiori rispetto ai nobili, uniti a una plasticità tonale e a una qualità materica dell’immagine che si accordano alle estetiche contemporanee della stampa opaca di pregio.
Chimica di processo, prassi di laboratorio e stabilità dell’immagine (1910–oggi)
La Callitipia è un processo a contatto che richiede un negativo della stessa dimensione della stampa finita, oggi spesso ricavato come internegativo digitale. Il cuore della procedura è la soluzione sensibilizzante, composta da ferrico ossalato (tipicamente al 20% in acqua deionizzata) e nitrato d’argento (intorno al 10%), miscelati appena prima della stesura con eventuale aggiunta di un tensioattivo (il Tween 20 è ricorrente) per favorire assorbimento e uniformità. La carta ideale è un cotone 100% a basso contenuto di carbonati, con collatura interna controllata; gli stampatori più esperti raccomandano acque demineralizzate e una disciplina rigorosa di pulizia (“acid‑wash” di vasche e pennelli) perché la sensibilità del sistema a ioni metallici e contaminanti è elevata e può generare velo o maculature. Una volta asciutto in ambiente povero di UV, il foglio si accoppia in cornice a pressione col negativo e si espone a UV: al termine, l’immagine è ancora latente, con ombre solo accennate. Si passa allora allo sviluppo in un riducente scelto in funzione del tono: citrato d’ammonio o citrato di sodio per bruni/seppia caldi e vellutati, acetato di sodio o ossalato di potassio per toni neutri‑freddi fino al nero. La comparsa è istantanea, come in platino/palladio, e la modulazione del tempo in sviluppo consente di regolare corpo e contrasto della stampa.
Dopo lo sviluppo, il momento critico è la chiarifica: bagni di acido citrico, bisolfito di sodio e/o EDTA tetrasodico rimuovono Fe(III)/Fe(II) residui e complessano eventuali specie indesiderate, impedendo al ferro di restare intrappolato nella fibra e catalizzare, col tempo, ingiallimenti nelle alte luci. La letteratura è concorde nell’attribuire proprio alla chiarifica insufficiente l’antica fama di impermanenza della Callitipia; quando eseguita con cura, la stampa sopporta esposizioni prolungate senza degradazione cromatica apprezzabile. Segue il viraggio opzionale, che oltre al valore estetico ha un forte impatto conservativo: oro per un nero più neutro e lustro ridotto, platino/palladio per innalzare la inerzia dell’immagine e ricondurla, chimicamente, a una struttura prossima alla platinotipia. Infine il fissaggio in tiosolfato rimuove argento non immagine e complessi residui, lasciando l’immagine in stato passivato; il lavaggio abbondante completa il ciclo. Molte scuole preferiscono la sequenza toning → fix, altre fix → toning: entrambe sono attestate, ma i sostenitori del viraggio prima del fissaggio sottolineano il vantaggio di operare su un’immagine argentica ancora ricettiva allo scambio metallico e già “ripulita” dal ferro.
Il controllo del contrasto è uno dei tratti che rendono la Callitipia così attuale. L’ossalato ferrico come sensibilizzante permette di coprire negativi con ampie escursioni di densità, e l’uso calibrato dei developer fornisce ulteriore leva; la combinazione con internegativi digitali – profilati tramite step wedge – consente una linearizzazione accurata della curva di risposta e, quindi, una ripetibilità che la stampa Van Dyke fatica a eguagliare. I vantaggi si pagano con la necessità di mettere a punto il proprio set carta/soluzioni/tempi: differenze tra carte in pH, in colla interna e in cariche minerali possono modificare la cinematica dell’immagine e il punto di nero. Non sorprende che le guide contemporanee raccomandino test di compatibilità carta e, se necessario, pre‑acidificazioni leggere del foglio per neutralizzare eventuali alcalinità. La gestione della luce di lavoro non è così vincolante come in camera oscura argentica: è sufficiente ridurre la componente UV prima della chiarifica; superata questa, la sensibilità residua diventa trascurabile e si può procedere alla finitura in luce ambiente.
Sul versante della stabilità, la Callitipia ben processata è convincente. I viraggi con metalli nobili proteggono dall’ossidazione atmosferica e dal sulfidation, e già in epoca contemporanea sono stati condotti stress test empirici di lunga durata su stampe trattate correttamente senza evidenza di fading. Le linee guida dei repertori tecnici ricordano però che la fragilità meccanica di ogni film colloidale su carta resta un dato: abrasioni, sfregamenti e pieghe possono intaccare i microcristalli d’argento con danni visibili nelle ombre continue. Per la conservazione preventiva si raccomandano UR moderata, temperatura stabile e intercalari privi di carbonati reattivi; in esposizione, la luminosità dovrà essere limitata, come per tutte le stampe storiche, e i neri – in specie quelli virati in oro – beneficiano di cornici con passpartout distanziatori. Anche la diagnosi scientifica trae beneficio dalla specificità chimica del processo: la XRF distingue Ag e i metalli di viraggio (Au, Pt, Pd), rivelando la presenza di nobili e, in alcuni casi, il profilo di zolfo residuo legato a fissaggi incompleti.
Un capitolo a parte riguarda il confronto tonale con i processi affini e con la platinotipia. In Callitipia, l’immagine è costituita da argento metallico (più o meno sostituito/ricoperto dal metallo nobile dopo il viraggio), con microstrutture che – a parità di superficie matte – conferiscono lustro leggermente superiore rispetto a un vero platino, specie nei toni medio‑scuri. L’uso di developer “freddi” e un viraggio diligente riducono al minimo questa differenza, che spesso scompare a occhio. Con Van Dyke, invece, la Callitipia dimostra neri più corposi e mezzitoni meno compressi proprio grazie alla cinematica develop‑out e alla chimica ossalato; il prezzo da pagare è una maggiore complessità di settaggio, che però oggi è ampiamente compensata dagli internegativi digitali.
Diagnosi, conservazione, rinascita contemporanea e confronto sistematico con Van Dyke, Argirotipia e Platinotipia (anni 1970–oggi)
L’attenzione rinnovata verso la Callitipia nasce negli anni Settanta‑Ottanta con la riscoperta dei processi storici e si consolida nel nuovo millennio grazie alla catena digitale. La logica è semplice: l’autore cerca una stampa opaca, con toni lunghi e neri pieni, più accessibile economicamente dei procedimenti a platino/palladio, ma più controllabile e profonda di un Van Dyke. La callitipia digitale consente di mappare la propria curva di risposta attraverso target calibrati e di generare un internegativo ottimizzato per la combinazione carta/sensibilizzatore/developer/viraggio. Questo ha prodotto una piccola rivoluzione di ergonomia: dove un tempo i risultati dipendevano molto dall’intuito empirico, oggi si può perseguire una ripetibilità professionale, con uno spessore tonale che sopporta bene anche grandi formati. La manualistica attuale – spesso scritta da stampatori‑ricercatori che hanno sistematizzato decenni di pratica – ribadisce gli stessi capisaldi: pulizia rigorosa, acque deionizzate, chiarifica metodica, viraggi consapevoli, e una gestione della luce che minimizzi la UV sino al completamento della chiarifica.
Per la diagnosi conservativa, distinguere Callitipia da processi limitrofi richiede uno sguardo insieme macroscopico e strumentale. La presenza di retinature o grane particolarmente fini e un lustro appena superiore rispetto al platino possono suggerire argento; un giallo nelle alte luci è indizio di chiarifica insufficiente e di ferro residuo. La spettroscopia XRF è la via maestra: rileva Ag e identifica eventuali Au/Pt/Pd di viraggio, distinguendo così una Callitipia virata da una vera platinotipia; nei casi di Argirotipia moderna, la firma del sulfammato d’argento può emergere indirettamente in relazione ai residui chimici, ma la distinzione principale resta cinematica (printing‑out vs develop‑out) e operativa, più che esclusivamente elementare. Laddove necessario, test microchimici distruttivi o microanalisi stratigrafiche possono confermare la morfochimica dell’immagine.
Il confronto con Van Dyke chiarisce bene il posizionamento della Callitipia. Con Van Dyke si lavora a partire da ferrico ammonio citrato e acido tartarico, si espone fino a formazione dell’immagine finale e si interviene con lavaggi e chiarifica senza vero developer. Il contrasto va più “di negativo” e meno “di processo”, e i toni sono tipicamente caldi e profondi, ma con mezzitoni che possono risultare più compressi. In Callitipia, il developer e l’eventuale viraggio danno una tavolozza più ampia: si può piegare la resa al caldo vellutato o al nero neutro, arrivando – con Pt/Pd – a una firma estetica del tutto prossima alla platinotipia. Questo spiega come mai, storicamente, Callitipie siano state confuse con stampe al platino, mentre la confusione con Van Dyke è soprattutto terminologica (specie in italiano, dove “stampa bruna” o “Callitipia” sono stati usati promiscuamente).
Quanto alla Argirotipia, la sua modernità chimica è legata al lavoro di Mike Ware, che sostituisce il nitrato d’argento con sulfammato d’argento nel sensibilizzatore, mantenendo la filosofia “printing‑out” e migliorando alcuni aspetti di chiarifica e shelf‑life delle soluzioni. La Callitipia resta invece ancorata al paradigma develop‑out e alla versatilità dei developer; i percorsi si incrociano nel linguaggio della stampa a contatto su carta di cotone e nella pratica dei negativi digitali, ma divergono nella microchimica e nel workflow. In termini di stabilità, entrambe le tecniche, se chiarificate e lavate con rigore e, nel caso della Callitipia, virate e fissate correttamente, soddisfano i criteri di archivio invocati dai conservatori; la Callitipia guadagna un ulteriore margine quando si scelgono viraggi in Pt/Pd, data la inerzia superiore di questi metalli.
La rinascita contemporanea della Callitipia, infine, è anche culturale. L’interesse per le texture opache, per i neri non speculari e per la materialità della carta ha reso nuovamente attraente un processo che invita a tempi lenti e a una manualità consapevole. In ambito didattico e museale, la Callitipia è un terreno ideale per raccontare la storia delle tecniche: recupera l’intuizione ottocentesca di Herschel sui sali di ferro, incrocia l’eredità dei processi a nobile e dialoga con il digitale attraverso il negativo calibrato. Il risultato, quando la catena è ben curata – sensibilizzazione, esposizione, sviluppo, chiarifica, viraggio, fissaggio, lavaggio, asciugatura – è una stampa che regge il confronto con qualsiasi fine art contemporanea: neri densi, mezzitoni estesi, alte luci pulite, e una tavolozza tonale che va dal seppia vellutato al nero antracite. In più, i costi inferiori rispetto ai nobili aprono la pratica a autori e laboratori che cercano un equilibrio fra sostenibilità e eccellenza. La Callitipia, oggi, è meno una “tecnica antica” e più un linguaggio che continua a reinventarsi, forte di una storia solida e di una chimica che gli stampatori hanno imparato a padroneggiare con precisione.
Fonti e riferimenti
- Sandy King, “The Kallitype Process”, AlternativePhotography.com
https://www.alternativephotography.com/the-kallitype-process/ - Kallitype, Wikipedia/Wikiwand
https://en.wikipedia.org/wiki/Kallitype
https://www.wikiwand.com/en/articles/Kallitype - Wynn White, “Kallitypes vs Vandykes”, AlternativePhotography.com
https://www.alternativephotography.com/kallitypes-vs-vandykes/ - Jacques Kevers, “The Iron‑Silver Processes” (Picto Benelux)
http://www.picto.info/feagdoc/feag_e.pdf - Robert Hirsch, “Kallitype and Vandyke Brown Print Processes”, Freestyle Photo
https://www.freestylephoto.com/kallitype-and-vandyke-brown-print-processes - Digitaltruth / Bostick & Sullivan, “Kallitype”
https://www.digitaltruth.com/products/bostick-sullivan_tech/kallitype.pdf - Photrio, “The chemistry of kallitypes”
https://www.photrio.com/forum/threads/the-chemistry-of-kallitypes.144668/ - Allan Chemical, “How Ferric Oxalate Works in Kallitype Printing”
https://allanchem.com/how-ferric-oxalate-works-in-kallitype-printing/ - Don Nelson, “Introduction to Kallitype, Vandyke Brown, and Argyrotype”, Routledge/Taylor & Francis
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9781003311812-2/introduction-kallitype-vandyke-brown-argyrotype-nelson - LabOldTech, “Kallitype / Kallitipia”
https://www.laboldtech.eu/metodiche/kallitipia/ - Massimo Talamini, “La Callitipia (Metodo Van Dyke o Stampa Bruna)”
https://www.massimotalamini.it/blog/2011/09/la-callitipia-metodo-van-dyke-o-stampa-bruna/
Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.