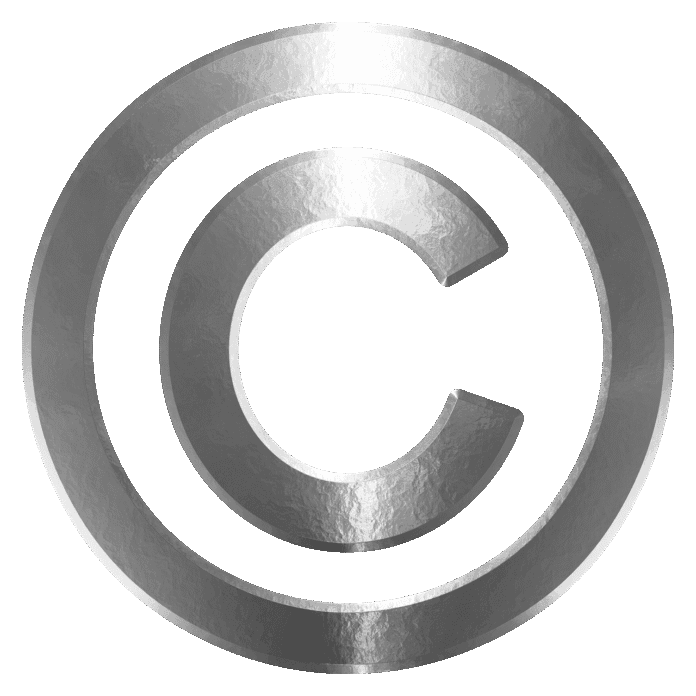Il rapporto tra fotografia e diritto d’autore è una delle questioni giuridiche più delicate e dibattute del diritto contemporaneo. A differenza delle altre arti visive, la fotografia si colloca in una zona di confine: da un lato è un atto meccanico, legato all’uso di strumenti tecnici, dall’altro è un atto creativo, che implica scelte di composizione, luce, prospettiva e interpretazione.
Stabilire quando una fotografia sia tutelata come opera dell’ingegno e quando, invece, resti confinata alla categoria dei prodotti documentali, ha occupato per decenni dottrina e giurisprudenza.
Questo articolo analizza in modo approfondito quattro nodi fondamentali:
- La distinzione tra fotografie creative e semplici fotografie.
- La durata della protezione in Italia, Unione Europea e Stati Uniti.
- La giurisprudenza che ha definito il concetto di originalità.
- La differenza tra diritto morale e diritto patrimoniale.
Fotografie creative e semplici fotografie
Il primo elemento che occorre chiarire è la distinzione giuridica tra due categorie principali: le opere fotografiche e le semplici fotografie.
Le opere fotografiche
Sono considerate opere fotografiche quelle che presentano un carattere creativo, vale a dire quando l’autore compie scelte personali che vanno oltre la mera riproduzione tecnica della realtà. Il fotografo, in questi casi, non si limita a “registrare” un soggetto, ma vi imprime la propria sensibilità artistica attraverso scelte di inquadratura, luce, tempi di esposizione, colore, post-produzione o persino nella costruzione scenografica.
In Italia, queste opere sono protette dagli articoli 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), equiparate alle altre opere dell’ingegno come la pittura o la scultura.
Esempi tipici:
- Fotografia d’arte e concettuale.
- Ritratti che mostrano una precisa scelta interpretativa.
- Fotografie di moda che puntano su scenografia e stilizzazione.
Le semplici fotografie
La categoria delle “semplici fotografie” è stata introdotta per distinguere quegli scatti che hanno un valore meramente documentativo. Non si richiede un apporto creativo particolare, ma solo la capacità di riprodurre fedelmente la realtà. La legge italiana ne ha riconosciuto la tutela a partire dal 1979 (art. 87 e seguenti della L. 633/1941), con protezione più limitata nel tempo e nell’estensione dei diritti.
Esempi tipici:
- Fotografie di documenti, prodotti o beni immobili per fini amministrativi.
- Fotografie di cronaca prive di particolari scelte artistiche.
- Riproduzioni fotografiche di dipinti o sculture.
La differenza tra le due categorie non è puramente accademica: comporta conseguenze giuridiche dirette in termini di durata della protezione, diritti spettanti all’autore e possibilità di utilizzo da parte di terzi.
Durata della protezione in Italia, UE e USA
Il secondo punto riguarda la durata della protezione del diritto d’autore, che varia in base alla categoria della fotografia e al contesto normativo nazionale.
Italia e Unione Europea
- Opere fotografiche creative: godono della protezione piena prevista per le opere dell’ingegno, pari a 70 anni dopo la morte dell’autore (art. 25 L. 633/1941, in armonia con la Direttiva UE 2006/116).
- Semplici fotografie: godono di una protezione più breve, pari a 20 anni dalla produzione dello scatto (art. 92 L. 633/1941).
Questa distinzione rappresenta un unicum nel panorama europeo: non tutti gli Stati membri hanno mantenuto la categoria delle “semplici fotografie” con una tutela ridotta. Alcuni Paesi, come la Germania, hanno progressivamente assorbito la distinzione, tendendo a considerare protetta come opera qualsiasi fotografia che presenti anche un minimo livello di creatività.
Stati Uniti
La legislazione statunitense adotta un approccio diverso. Con il Copyright Act del 1976 e le successive modifiche:
- Le opere fotografiche realizzate da autori individuali dopo il 1978 sono protette per tutta la vita dell’autore più 70 anni.
- Per le opere realizzate come work for hire (tipiche delle agenzie fotografiche, pubblicità e editoria), la protezione dura 95 anni dalla pubblicazione o 120 anni dalla creazione, a seconda di quale periodo scade prima.
La distinzione tra fotografia creativa e non creativa non esiste in maniera così netta come in Italia: negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha più volte ribadito che anche un livello minimo di creatività è sufficiente a garantire tutela.
La giurisprudenza sul concetto di originalità
Il concetto di originalità è il cardine attorno a cui ruota l’intero dibattito sul diritto d’autore in fotografia. Negli anni, numerose sentenze hanno contribuito a definire i parametri con cui valutare se una fotografia sia un’opera dell’ingegno.
Giurisprudenza italiana
In Italia, la giurisprudenza tende a riconoscere come creative tutte le fotografie in cui l’autore abbia compiuto scelte non banali. Ad esempio, i tribunali hanno riconosciuto creatività in:
- fotografie pubblicitarie con particolari allestimenti scenografici;
- fotografie di moda e ritratti con uso innovativo della luce;
- reportage che presentavano un taglio stilistico e narrativo originale.
La semplice riproduzione di un’opera d’arte, invece, viene di solito considerata semplice fotografia, in quanto atto meramente tecnico.
Giurisprudenza europea
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza Infopaq, 2009) ha stabilito che un’opera è protetta dal diritto d’autore quando riflette la “personalità dell’autore”. Applicata alla fotografia, questa dottrina ha spostato l’ago della bilancia a favore di una tutela più ampia, anche per fotografie non immediatamente artistiche.
Giurisprudenza statunitense
Il caso più noto è Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony (1884), in cui la Corte Suprema ha riconosciuto come protetta dal copyright una fotografia di Oscar Wilde realizzata da Napoleon Sarony, sottolineando che l’autore aveva compiuto scelte artistiche su posa, illuminazione e inquadratura.
Questo caso è considerato il precedente fondativo per la tutela delle fotografie negli USA.
Diritto morale e diritto patrimoniale
Il diritto d’autore si articola in due componenti fondamentali: diritti morali e diritti patrimoniali.
I diritti morali
I diritti morali riguardano il legame personale dell’autore con l’opera. In Italia, essi comprendono:
- il diritto alla paternità dell’opera (essere riconosciuto come autore);
- il diritto all’integrità (opporsi a modifiche che snaturino l’opera);
- il diritto di ritiro dal commercio per motivi etici o morali.
Questi diritti sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. Sopravvivono anche dopo la morte dell’autore, potendo essere fatti valere dagli eredi.
I diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali riguardano invece lo sfruttamento economico dell’opera, come:
- il diritto di riproduzione;
- il diritto di diffusione e distribuzione;
- il diritto di elaborazione o adattamento.
Questi diritti sono cedibili e hanno durata limitata nel tempo (70 anni post mortem per opere fotografiche creative).
La distinzione è cruciale: mentre i diritti patrimoniali regolano l’uso commerciale delle fotografie, i diritti morali garantiscono sempre all’autore un controllo sulla dignità e sulla corretta attribuzione della sua opera.
Il diritto d’autore nella fotografia rappresenta un terreno complesso, in bilico tra la dimensione tecnica e quella artistica. La distinzione tra fotografie creative e semplici fotografie, la diversa durata della protezione nei vari ordinamenti, le interpretazioni giurisprudenziali sull’originalità e la doppia natura dei diritti (morali e patrimoniali) dimostrano come la fotografia sia un caso unico nel panorama del diritto.
Le sfide contemporanee — dalla circolazione digitale alla manipolazione tramite AI — non fanno che rendere più urgente un chiarimento normativo e culturale sullo statuto giuridico dell’immagine fotografica.
Mi chiamo Alessandro Druilio e da oltre trent’anni mi occupo di storia della fotografia, una passione nata durante l’adolescenza e coltivata nel tempo con studio, collezionismo e ricerca. Ho sempre creduto che la fotografia non sia soltanto un mezzo tecnico, ma uno specchio profondo della cultura, della società e dell’immaginario di ogni epoca. Su storiadellafotografia.com condivido articoli, approfondimenti e curiosità per valorizzare il patrimonio fotografico e raccontare le storie, spesso dimenticate, di autori, macchine e correnti che hanno segnato questo affascinante linguaggio visivo.