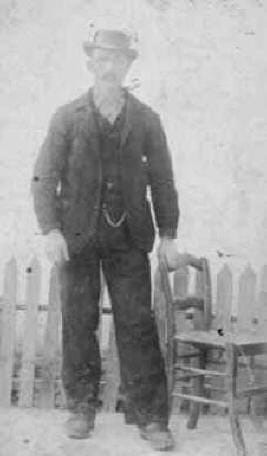La crisotipia, o Chrysotype, è uno dei processi fotografici più affascinanti e longevi della storia, introdotto nel 1842 da Sir John Frederick William Herschel (1792 – 1871). Herschel, matematico, astronomo e chimico britannico, fu una figura centrale nello sviluppo della fotografia ottocentesca: a lui si devono la scoperta e l’applicazione del tiosolfato di sodio come fissaggio (1839), l’invenzione del termine “fotografia” e lo studio di numerosi procedimenti alternativi al dagherrotipo e al calotipo.
Nel 1842, due anni dopo la presentazione ufficiale del calotipo di Talbot, Herschel rese noto alla Royal Society un procedimento che sfruttava la fotosensibilità dei sali d’oro. Questo nuovo metodo, battezzato Crisotipia dal greco “χρυσός” (oro) e “τύπος” (impronta), aveva come obiettivo la realizzazione di immagini fotografiche stabili nel tempo, caratterizzate da una tonalità cromatica peculiare e da un’elevata resistenza al deterioramento.
Il contesto storico della sua nascita è determinante. Dagherrotipia e calotipia avevano già polarizzato l’attenzione del pubblico e degli scienziati, ma entrambe presentavano problemi: la prima produceva un’immagine unica, difficile da copiare, mentre la seconda soffriva di instabilità e scarsa definizione. Herschel, convinto che la chimica dei metalli nobili potesse offrire soluzioni migliori, iniziò a sperimentare l’uso dell’oro come agente fotosensibile.
La crisotipia, nelle sue prime formulazioni, consisteva nell’impregnare un foglio di carta di cloruro d’oro (AuCl₃) in soluzione, esponendolo poi alla luce solare attraverso un negativo o un oggetto traslucido. L’azione dei fotoni riduceva gli ioni aurici (Au³⁺) ad oro metallico colloidale, che si fissava alle fibre della carta, dando vita a un’immagine dai toni bruni, rossastri o purpurei.
Il processo apparve subito promettente per la sua stabilità. Herschel sottolineò infatti come l’oro, a differenza dell’argento, fosse meno incline all’ossidazione e al deterioramento causato da agenti atmosferici. Tuttavia, la sua diffusione fu limitata da diversi fattori: il costo elevato dei sali d’oro, la difficoltà di ottenere esposizioni uniformi e la complessità del procedimento rispetto alle tecniche concorrenti.
Nonostante queste limitazioni, la crisotipia rimase una curiosità di laboratorio apprezzata per la sua eleganza e per l’alone di preziosità che il metallo nobile conferiva all’immagine. Già negli anni Quaranta dell’Ottocento, venne adottata in ambiti ristretti da dilettanti colti e scienziati sperimentatori. Herschel stesso la utilizzò per dimostrare le potenzialità di metalli diversi dall’argento, aprendo così la strada ad altri processi metallici come la cianotipia (1842, a base di ferro) e la platinotipia (1873, a base di platino).
Il periodo 1842 – 1850 segnò dunque la fase pionieristica della crisotipia: un decennio di curiosità, di sperimentazioni limitate e di progressiva marginalizzazione rispetto ad altri procedimenti più pratici. Tuttavia, l’intuizione di Herschel restò viva, riaffiorando più volte nella storia successiva della fotografia come possibilità di coniugare chimica nobile, estetica raffinata e durata nel tempo.
Aspetti chimici del processo con sali d’oro
La forza e la particolarità della crisotipia risiedono nelle sue basi chimiche. L’impiego dell’oro, metallo nobile per eccellenza, conferisce all’immagine una resistenza alla corrosione e una stabilità cromatica superiori a quelle dei processi a base d’argento.
Il nucleo del procedimento è la reazione fotochimica di riduzione: gli ioni aurici (Au³⁺), presenti in soluzione di cloruro d’oro, vengono ridotti dalla luce a particelle di oro metallico (Au⁰). Questo avviene grazie al ruolo della luce come catalizzatore, che libera elettroni capaci di trasformare gli ioni aurici. Il risultato è la formazione di un deposito microscopico di oro colloidale all’interno delle fibre della carta.
La chimica può essere descritta in maniera schematica:
AuCl₃ + 3e⁻ → Au⁰ + 3Cl⁻
La distribuzione e la dimensione delle particelle di oro determinano il colore finale dell’immagine. L’oro colloidale, a seconda del diametro delle particelle, può assumere tonalità che vanno dal rosso porpora al bruno seppia, fino a riflessi violacei o dorati. Questo fenomeno, noto come assorbimento plasmonico, è alla base delle sfumature cromatiche uniche della crisotipia.
Il procedimento originale di Herschel prevedeva diverse varianti, spesso sperimentali, ma la sequenza base era la seguente:
Preparazione della carta: il foglio veniva immerso in una soluzione diluita di cloruro d’oro, talvolta con l’aggiunta di sostanze ossidanti come il clorato di potassio.
Essiccazione: il foglio impregnato veniva asciugato al buio per evitare annerimenti spontanei.
Esposizione: la carta sensibilizzata veniva collocata sotto un negativo e esposta alla luce solare per tempi lunghi, spesso superiori a mezz’ora.
Sviluppo e fissaggio: l’immagine latente veniva intensificata con bagni riducenti (talvolta con soluzioni a base di ossalato di ferro o altri reagenti), quindi fissata per eliminare i residui non ridotti.
La chimica della crisotipia presenta alcune peculiarità. In primo luogo, la scarsa fotosensibilità dei sali d’oro rispetto a quelli d’argento rendeva necessari tempi di esposizione molto lunghi, limitando la praticità del metodo. In secondo luogo, il costo elevato del cloruro d’oro costituiva un ostacolo per una diffusione su larga scala.
Nonostante queste difficoltà, la stabilità del risultato finale era eccezionale: un’immagine in oro, a differenza di una in argento, non si ossida facilmente, né annerisce a contatto con zolfo o cloro presenti nell’aria. La crisotipia offriva dunque una durabilità teoricamente secolare, tanto che molte stampe ottocentesche sono giunte fino a noi in condizioni eccellenti.
Nel corso del XIX e XX secolo, diversi chimici e fotografi sperimentarono varianti della crisotipia, introducendo agenti sensibilizzanti a base di ferro (ferrici ammonici, citrati ferrici) per rendere più rapida la riduzione dell’oro. Queste evoluzioni portarono a una maggiore sensibilità alla luce, pur mantenendo la stabilità originaria del processo.
L’aspetto più affascinante della chimica della crisotipia è la combinazione di un metallo nobile con il supporto organico della carta: un incontro tra un materiale di altissimo valore simbolico e uno di uso quotidiano. Questo connubio conferisce al processo un carattere ibrido, tra artigianato e preziosità, che lo distingue nettamente dalle altre tecniche fotografiche.
Applicazioni estetiche e sperimentazioni nel XIX e XX secolo
Sebbene la crisotipia non si sia mai imposta come processo di massa, essa ha esercitato una forte attrazione estetica e sperimentale su diversi fotografi, soprattutto per la qualità cromatica delle immagini prodotte.
Nel XIX secolo la crisotipia rimase perlopiù confinata a circoli scientifici e artistici ristretti. Alcuni dilettanti colti, attratti dalla novità dell’oro come mezzo di rappresentazione, realizzarono stampe di ritratti, paesaggi e nature morte. L’effetto cromatico, tendente a un bruno caldo o a un rosso violaceo, conferiva alle immagini un’aura quasi pittorica, tanto da avvicinarle alla sensibilità estetica dei pittorialisti della seconda metà del secolo.
La marginalità commerciale del procedimento non impedì che esso venisse riscoperto periodicamente. Già negli anni Settanta dell’Ottocento, con la diffusione della platinotipia, la crisotipia venne rivalutata come alternativa artistica, benché rimanesse meno accessibile per il costo ancora superiore dell’oro rispetto al platino. Alcuni artisti e fotografi sperimentatori, in particolare in Francia e in Inghilterra, ne apprezzarono la delicatezza tonale e la durata.
Nel XX secolo la crisotipia entrò a far parte di quel vasto movimento di recupero dei processi storici che coinvolse artisti, storici e tecnici. Con la progressiva industrializzazione della fotografia a gelatina d’argento, diversi autori sentirono il bisogno di esplorare procedimenti alternativi, più lenti e artigianali, capaci di restituire un rapporto diretto con la materia fotografica.
In questo contesto, la crisotipia venne adottata come mezzo espressivo di nicchia, capace di produrre immagini uniche, irripetibili, con un carattere prezioso. Alcuni fotografi modernisti, come gli sperimentatori legati alla Scuola di Bauhaus, studiarono le possibilità cromatiche dei processi metallici, compresa la crisotipia, per ottenere variazioni tonali inedite.
La particolarità cromatica delle immagini in oro trovò applicazione anche in ambito bibliografico e museale. Diverse istituzioni, tra Ottocento e Novecento, produssero tavole illustrative in crisotipia per pubblicazioni di pregio, sfruttando la lunga durata e la ricchezza cromatica del processo. In questo senso, la crisotipia non fu mai un fenomeno di massa, ma piuttosto una tecnica destinata a edizioni limitate, collezioni private e sperimentazioni artistiche.
Durante il XX secolo, l’interesse accademico verso i processi antichi condusse a nuove ricerche sulla chimica della crisotipia. Studiosi come Lionel Marks e, più recentemente, Mike Ware, hanno indagato i meccanismi fotochimici alla base della riduzione dell’oro, perfezionando le ricette e adattandole a materiali moderni.
La crisotipia, con i suoi colori unici e la sua stabilità straordinaria, è così rimasta una sorta di filo sotterraneo nella storia della fotografia: mai dominante, ma sempre presente come alternativa nobile e preziosa alle tecniche più comuni.
Rinascita contemporanea e uso artistico odierno
Dalla seconda metà del XX secolo fino a oggi, la crisotipia ha conosciuto una rinascita significativa, soprattutto grazie al movimento della fotografia alternativa e al crescente interesse verso i processi storici.
Artisti e fotografi contemporanei hanno riscoperto la crisotipia come tecnica in grado di coniugare artigianalità, unicità e durata, caratteristiche che contrastano con la riproducibilità e la volatilità delle immagini digitali. La possibilità di produrre stampe in oro, con sfumature cromatiche che variano a seconda della preparazione chimica, ha reso questo procedimento un linguaggio espressivo distintivo.
Oggi la crisotipia viene praticata in laboratori specializzati e da fotografi-artisti che ne apprezzano la lentezza e la complessità. Le formule moderne, perfezionate da studiosi come Mike Ware, prevedono l’uso di citrato ferrico ammonico come agente sensibilizzante, combinato con cloruro d’oro. In questo caso, la riduzione fotochimica avviene attraverso un doppio meccanismo: la luce riduce il ferro da Fe³⁺ a Fe²⁺, il quale a sua volta riduce gli ioni aurici ad oro metallico. Questa catena di reazioni aumenta la sensibilità e rende il processo più controllabile.
Le stampe ottenute in epoca contemporanea mostrano una gamma cromatica ampia, che può essere modulata variando le concentrazioni chimiche, i tempi di esposizione e i metodi di sviluppo. I colori vanno dal rosso porpora intenso al seppia caldo, fino a sfumature quasi neutre, rendendo la crisotipia estremamente versatile dal punto di vista estetico.
Il fascino odierno della crisotipia deriva anche dalla sua valenza simbolica: l’uso dell’oro, metallo da sempre associato alla preziosità e all’eternità, conferisce alle immagini un’aura di rarità e sacralità. In un’epoca dominata dalla produzione di massa, la crisotipia rappresenta un ritorno all’unicità dell’opera fotografica, intesa come oggetto artistico irripetibile.
Dal punto di vista tecnico, le versioni moderne della crisotipia beneficiano di strumenti e conoscenze che Herschel non poteva avere: esposizioni calibrate con lampade UV, carte di qualità museale, reagenti purificati. Ciò ha permesso di ottenere risultati più costanti e riproducibili, mantenendo però il carattere artigianale e la variabilità tonale del processo.
L’uso contemporaneo della crisotipia si colloca principalmente in due ambiti: quello artistico-espressivo, con fotografi che ne fanno un linguaggio personale per opere destinate a gallerie e collezioni, e quello didattico-sperimentale, con laboratori e scuole che lo propongono come esempio di chimica applicata alla fotografia.
In definitiva, la crisotipia ha attraversato quasi due secoli di storia, dalla sua invenzione nel 1842 fino al presente, mantenendo intatta la sua capacità di affascinare per la combinazione unica di scienza, arte e preziosità materiale. Ciò che era nato come un esperimento scientifico di Herschel continua oggi a vivere come pratica artistica, dimostrando che la fotografia, oltre che tecnologia, è sempre stata anche materia di alchimia visiva.
Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.