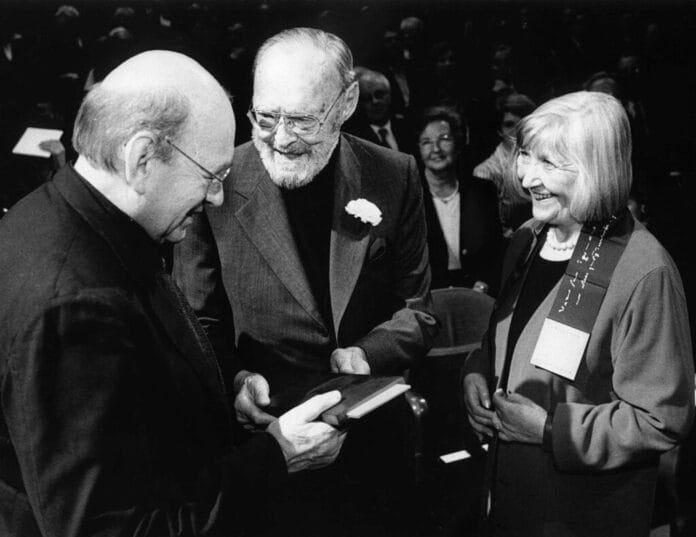Bernd Becher nacque a Siegen, in Germania, nel 1931, in un contesto profondamente legato all’industria mineraria e siderurgica della Renania Settentrionale-Vestfalia. Hilla Wobeser, che sarebbe poi diventata Hilla Becher, nacque a Potsdam nel 1934. Entrambi crebbero in un Paese segnato dalla guerra, dalle distruzioni e da una fase di intensa ricostruzione industriale. Questo background non solo plasmò il loro immaginario, ma definì anche l’orizzonte culturale in cui si sarebbero mossi. Bernd Becher studiò pittura e grafica pubblicitaria, interessandosi progressivamente alla fotografia come strumento documentario capace di restituire la precisione formale delle strutture industriali. Hilla, formatasi come fotografa in un laboratorio berlinese, sviluppò un metodo rigoroso di stampa e ripresa che si sarebbe rivelato decisivo nell’elaborazione del loro linguaggio comune.
Il loro incontro avvenne alla Kunstakademie di Düsseldorf alla fine degli anni Cinquanta, quando Bernd aveva già iniziato a fotografare impianti industriali destinati alla demolizione. Hilla portò in questo sodalizio la sua competenza tecnica e una sensibilità attenta alla serialità, mentre Bernd apportava la forza concettuale e la consapevolezza artistica di un progetto di lunga durata. Dal 1959, data ufficiale dell’inizio della loro collaborazione, cominciarono a elaborare una metodologia fotografica che li avrebbe resi pionieri della fotografia oggettiva tedesca. Il matrimonio artistico e personale li unì fino alla morte di Bernd nel 2007, dopo quasi cinquant’anni di lavoro condiviso, continuato da Hilla fino alla sua scomparsa nel 2015.
Questa unione biografica e professionale è cruciale: la loro fotografia non può essere scissa tra individualità, poiché il metodo, l’estetica e la filosofia documentaria furono costruiti a quattro mani. Essi concepirono la fotografia come una pratica sistematica, volta a costituire archivi visivi di archeologia industriale, documentando forme architettoniche che stavano scomparendo sotto la pressione della modernizzazione.
Metodo fotografico e rigore sistematico
Il linguaggio dei Becher è noto per la sua apparente freddezza, ma dietro l’asetticità si cela un processo di scelta estetica radicale. Ogni fotografia veniva realizzata con macchina fotografica di grande formato, solitamente una Linhof o altre camere a soffietto, con obiettivi standard che garantivano la massima neutralità prospettica. La scelta del bianco e nero rispondeva all’esigenza di eliminare distrazioni cromatiche e di privilegiare le forme geometriche degli edifici. L’uso sistematico di una luce diffusa e priva di ombre nette, spesso ottenuta nelle ore mattutine o con cielo coperto, consentiva di ridurre i contrasti e mantenere una leggibilità costante delle strutture.
Il soggetto privilegiato erano i serbatoi, le torri d’acqua, i forni, i silos, i complessi minerari, le cokerie e le fabbriche dell’Europa occidentale e successivamente degli Stati Uniti. Questi oggetti non venivano trattati come ruderi pittoreschi ma come esemplari tipologici. I Becher concepirono la fotografia come tipologia, cioè una classificazione visiva: ogni immagine entrava a far parte di una serie, confrontabile con altre dello stesso genere. Questa impostazione derivava tanto dalle scienze naturali quanto dall’archeologia e dall’etnografia, ma la trasposizione nel campo della fotografia conferì una nuova dignità artistica a ciò che era fino ad allora considerato semplice documentazione tecnica.
Il risultato era una fotografia dalla frontalità rigorosa, senza effetti drammatici o concessioni alla retorica visiva. L’inquadratura centrata, l’orizzonte costantemente equilibrato e l’assenza di figure umane accentuavano l’idea di oggetti osservati in modo impersonale. Tuttavia, proprio in questa neutralità si manifesta la cifra stilistica: eliminando la componente soggettiva, i Becher elevavano il documento industriale a opera d’arte concettuale.
Un aspetto fondamentale del loro metodo fu la costruzione di tavole tipologiche, cioè griglie di nove o più fotografie che accostavano variazioni di una stessa tipologia architettonica. Questa modalità di presentazione spostava l’attenzione dal singolo scatto alla relazione tra più immagini, sottolineando analogie e differenze minime. Il fruitore era invitato a leggere le fotografie come se fossero tavole comparative di un atlante scientifico. L’effetto estetico nasceva proprio dalla serialità, trasformando elementi funzionali e banali in un linguaggio formale di straordinaria coerenza.
Le opere principali e la Scuola di Düsseldorf
Il corpus dei Becher è sterminato, frutto di decenni di esplorazioni in Germania, Francia, Belgio, Inghilterra e Stati Uniti. Le loro pubblicazioni e mostre divennero punti di riferimento non solo per la fotografia, ma anche per l’arte concettuale e l’architettura. Tra le opere principali si possono ricordare:
“Anonyme Skulpturen” (1970): la loro prima grande raccolta, pubblicata in collaborazione con la galleria Art & Project di Amsterdam, che sancì l’ingresso della loro ricerca nell’ambito dell’arte contemporanea.
Serie delle torri d’acqua: fotografie realizzate soprattutto in Germania e negli Stati Uniti, che mostrano la varietà formale di queste strutture, trasformandole in un inventario estetico.
Serie delle case a graticcio della Ruhr: un’indagine parallela agli edifici industriali, rivolta all’architettura vernacolare.
Serie dei forni per coke e delle miniere: documentazioni minuziose di un paesaggio industriale in via di sparizione, oggi considerate fonti di primaria importanza storica oltre che artistiche.
Mostra al Museum of Modern Art di New York (1974): segnò la consacrazione internazionale della loro opera.
Il loro insegnamento alla Kunstakademie di Düsseldorf fu altrettanto determinante. Dal 1976, Bernd Becher divenne professore di fotografia e, insieme a Hilla, formò una generazione di fotografi che sarebbe stata nota come Scuola di Düsseldorf. Tra gli allievi più celebri figurano Andreas Gursky, Candida Höfer, Thomas Struth, Thomas Ruff: ciascuno sviluppò un linguaggio personale, ma tutti ereditarono il rigore sistematico, l’attenzione al formato monumentale e la riflessione sulla fotografia come documento e come arte.
In questo senso, i Becher non furono soltanto fotografi, ma maestri di metodo, capaci di fondare una tradizione che avrebbe segnato la fotografia contemporanea a livello internazionale. La loro influenza travalicò il campo specifico della fotografia industriale, raggiungendo l’arte concettuale, la storia dell’architettura e persino la sociologia del lavoro.
Riconoscimenti, influenza e attualità
Nel corso della loro carriera, Bernd e Hilla Becher ottennero riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 1990. Le loro opere entrarono nelle collezioni permanenti dei più importanti musei del mondo, dal MoMA di New York al Centre Pompidou di Parigi, fino alla Tate di Londra. La loro fotografia fu apprezzata tanto dal mondo dell’arte quanto dagli storici dell’industria, che ne riconobbero il valore documentario.
L’influenza esercitata dai Becher è immensa. Il loro approccio metodico anticipò pratiche concettuali fondate sulla catalogazione e sulla serialità, avvicinandoli a figure come Sol LeWitt e agli artisti minimalisti. La loro capacità di trasformare un oggetto banale e funzionale in un elemento di pura forma li rese centrali nel dibattito sull’ontologia della fotografia: era possibile produrre arte senza interpretazione soggettiva? I Becher risposero dimostrando che la neutralità metodica è essa stessa una scelta estetica.
Dopo la morte di Bernd nel 2007, Hilla continuò a portare avanti il lavoro, curando mostre e pubblicazioni fino alla propria scomparsa nel 2015. Oggi il loro archivio, gestito dalla Fondazione Becher, rappresenta una delle più vaste collezioni fotografiche dedicate al paesaggio industriale europeo e americano. Le loro immagini, oltre a costituire opere d’arte, sono diventate fonti per la storia economica e sociale, documentando strutture che in gran parte non esistono più.
L’attualità della loro lezione si manifesta in diversi ambiti. Nel campo della fotografia contemporanea, molti autori riprendono la pratica della serialità e della catalogazione tipologica. Nell’ambito accademico, le loro opere sono studiate come esempi di fotografia oggettiva, categoria che ha ridisegnato i confini tra documento e arte. Persino nel dibattito sulla conservazione del patrimonio industriale, i Becher sono spesso citati per aver contribuito alla sensibilizzazione pubblica verso strutture che altrimenti sarebbero state cancellate senza lasciare traccia.
Il loro lavoro, rigoroso e impersonale, continua a suscitare dibattiti: si tratta di pura documentazione o di arte concettuale? La risposta, forse, sta proprio nell’impossibilità di tracciare una linea netta. Le fotografie dei Becher sono documenti perché descrivono con precisione strutture reali, ma sono anche arte perché operano una scelta, definiscono un metodo e propongono una visione. Questa tensione tra oggettività e estetica resta il cuore della loro opera e la ragione della loro perdurante attualità.
Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.