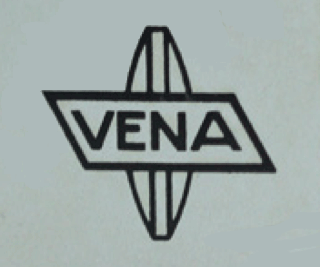Nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, l’Europa si trovava in piena ricostruzione industriale. In questa fase, anche i Paesi Bassi avviarono iniziative produttive in settori ad alta intensità tecnologica, tra cui l’ottica di precisione e la meccanica fotografica. È in questo scenario che, ad Amsterdam, prese forma la Vena N.V., acronimo del nome completo in olandese: Optische en Fotografische Apparatenfabrik, ovvero “Fabbrica di apparecchi ottici e fotografici”. La fondazione formale risale ai primi mesi del 1940, ma l’attività manifatturiera vera e propria, e in particolare la produzione di fotocamere, ebbe inizio solo tra il 1947 e il 1948.
Il ritardo produttivo non fu casuale. Durante il conflitto, la Vena rimase in uno stato embrionale, con attività limitate a progettazioni su carta e approvvigionamenti strategici. La scarsità di materie prime, unita alla difficile situazione geopolitica dei Paesi Bassi sotto occupazione tedesca, impedì ogni tipo di output industriale di tipo fotografico. Solo dopo la liberazione del 1945 fu possibile dare corpo ai primi prototipi, sfruttando la parziale smobilitazione delle tecnologie ottiche impiegate durante la guerra e l’accesso, per quanto parziale, a forniture tedesche.
L’impianto di produzione, situato nella cintura industriale sud-occidentale di Amsterdam, si sviluppava su circa 1500 metri quadrati. La struttura ospitava linee di tornitura, lenti ottiche in vetro crown e flint, camere di trattamento antiriflesso a vuoto, e banchi di collimazione ottica. Il personale era costituito da tecnici provenienti da altre aziende di precisione e da ex-militari specializzati nella manutenzione di ottiche da ricognizione.
Il contesto competitivo in cui Vena si inseriva era già affollato e in forte ripresa. Marchi come Robot, Wirgin, Agfa, Dacora e Voigtländer stavano lanciando modelli compatti destinati alla classe media europea, affamata di consumo ma ancora economicamente fragile. Per imporsi, la Vena optò per un approccio tecnico-pragmatico, con la produzione di fotocamere leggere, semplici, ma dotate di alcune soluzioni ottiche e meccaniche innovative.
La produzione effettiva di Vena fu estremamente limitata sia in quantità che in varietà. Si hanno testimonianze concrete dell’esistenza di due modelli principali, identificati comunemente come Vena 1 e Vena 2, anche se la denominazione ufficiale risulta poco documentata a livello di cataloghi o pubblicazioni industriali. Le fotocamere Vena erano del tipo a rullino 35 mm, con trasporto manuale della pellicola e chassis in lega di alluminio stampato.
Il Vena 1 era una fotocamera a telemetro fisso, non intercambiabile, con ottica anastigmatica da 50 mm f/3.5, basata su uno schema triplet modificato di derivazione Cooke. Il barilotto dell’obiettivo era in ottone cromato e incorporava un semplice sistema di messa a fuoco a vite elicoidale, con scala in metri da 1 m all’infinito. Il diaframma, del tipo a cinque lamelle, permetteva aperture da f/3.5 a f/16. L’otturatore era un centrale a lamelle, prodotto internamente dalla stessa Vena su licenza modificata del sistema Prontor, con tempi di esposizione da 1/25 a 1/200 di secondo più posa B.
Il Vena 2, molto più raro, era una versione leggermente avanzata dotata di telemetro accoppiato e mirino galileiano a correzione di parallasse, integrato in una scocca unificata. La lente anteriore manteneva lo stesso schema ottico ma con miglior trattamento antiriflesso, ottenuto per vaporizzazione in camera a vuoto con fluoruri di magnesio. Questo trattamento, raro per l’epoca in apparecchi non professionali, migliorava sensibilmente la trasmissione luminosa e riduceva i riflessi parassiti.
Entrambi i modelli utilizzavano una leva meccanica laterale per l’avanzamento della pellicola, con un sistema di blocco a fine corsa e contatore automatico dei fotogrammi. Il dorso posteriore era incernierato e dotato di una finestra di controllo con otturatore interno. Il pressapellicola era in acciaio inox molato, e la sede della pellicola era compatibile con cartucce standard tipo Kodak 135.
Uno dei dettagli più singolari delle Vena era l’impiego di una piastra ottica frontale removibile, che permetteva una parziale manutenzione dell’obiettivo senza dover smontare l’intera fotocamera. Questo sistema, simile a quello che sarà usato da Canon e Zorki negli anni ’50, era pensato per l’utenza amatoriale avanzata e rappresentava un tentativo di democratizzare la manutenzione ottica.
La costruzione delle fotocamere Vena rifletteva la doppia influenza della scuola meccanica tedesca prebellica e del razionalismo industriale olandese. La scocca era fresata a controllo semi-manuale da blocchi di lega leggera alluminio-zinco, successivamente anodizzata in nero opaco o cromata. Il peso complessivo si aggirava attorno ai 530 grammi, un valore intermedio tra compattezza e robustezza.
La trasmissione dell’avanzamento pellicola era affidata a un complesso sistema di ruote dentate in ottone, montate su assi in acciaio brunito e lubrificate con grassi siliconici. La resistenza meccanica di questo sistema fu valutata positivamente nei test condotti da riviste tecniche dell’epoca, che lo confrontavano con i sistemi analoghi delle Agfa Silette. La leva di caricamento dell’otturatore, posta in posizione laterale rispetto alla lente, permetteva un riarmo indipendente dallo scatto, evitando il rischio di doppia esposizione involontaria.
Particolare cura venne data alla lavorazione delle camme di sincronizzazione dell’otturatore con l’apertura del diaframma, garantendo una temporizzazione di ±1/200 s entro un margine d’errore di soli 4 millisecondi, fatto notevole per apparecchi semi-artigianali. Anche la filettatura interna del corpo ottico rispettava standard metrici compatibili con alcune ottiche prodotte in Germania (M39), anche se non ufficialmente compatibili.
Un altro elemento caratterizzante era il mirino, ottenuto mediante due lenti planoconvesse con rivestimento antiriflesso, e con tracciatura interna serigrafata per indicazione dell’inquadratura effettiva. Il mirino non era accoppiato a sistema di esposizione né integrava cellule fotoelettriche, essendo completamente manuale. Tuttavia, una rara variante della Vena 2, identificata da alcuni collezionisti come “Vena 2E”, mostrava una staffa laterale per l’aggiunta di esposimetri esterni tipo Bertram o Gossen.
Le finiture erano di ottima qualità, con incisioni al laser per numerazione di serie, verniciatura bivalente (nero e argento), e logotipo inciso nella calotta superiore. Le impugnature laterali erano rivestite in pelle bovina testurizzata, cucita a mano.
Nonostante l’alto livello di progettazione e la buona fattura costruttiva, la Vena scontò gravi difficoltà economiche e distributive. L’assenza di una rete commerciale internazionale, unita alla concorrenza spietata di giganti come Zeiss Ikon, Kodak e le emergenti ditte giapponesi, ne limitarono fortemente la diffusione. La produzione stimata non superò le 2.500 unità complessive, di cui circa 1.800 del modello Vena 1 e 600-700 del Vena 2, numero inferiore anche alle piccole case italiane come Rectaflex o Gami.
Nel 1951, a soli tre anni dall’inizio della produzione, la ditta fu ufficialmente dissolta. Le cause furono molteplici: la scarsità di capitali, la difficoltà nell’approvvigionamento dei vetri ottici di precisione, e la rapida obsolescenza tecnologica imposta dalla rivoluzione asiatica in ambito fotografico. La Vena non riuscì mai a progettare un sistema reflex né un corpo macchina a ottiche intercambiabili, perdendo rapidamente terreno rispetto alle esigenze emergenti del mercato.
Oggi le fotocamere Vena sono considerate pezzi da collezione molto rari. Le aste internazionali le valutano, a seconda delle condizioni e della presenza dell’astuccio originale in cuoio, tra i 600 e i 1.500 euro. Le versioni Vena 2 con trattamento multistrato hanno valore superiore per la rarità del trattamento antiriflesso in epoca pre-coating industriale di massa. I pochi esemplari esistenti sono generalmente conservati in collezioni olandesi e tedesche, mentre solo raramente compaiono in esposizioni museali dedicate alla fotografia meccanica del dopoguerra.
Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.
Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.
La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.
Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.
Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.
Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.