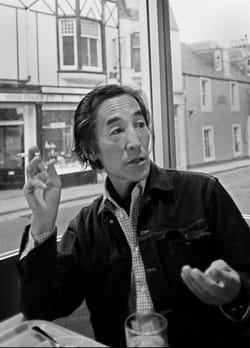Nascita e morte. Hiroshi Hamaya (濱谷 浩) nacque a Shitaya, nel quartiere di Ueno a Tokyo, il 28 marzo 1915, e morì in Giappone il 6 marzo 1999 all’età di 83 anni, dopo una carriera attiva per oltre sei decenni nella fotografia documentaria e paesaggistica. Fu il primo fotografo giapponese a entrare in Magnum Photos (1960) e ricevette premi di rilievo come l’Infinity Award – Master of Photography dell’International Center of Photography (1986) e l’Hasselblad Award (1987)
Formazione tecnica, metodi di lavoro e costruzione di uno sguardo (1915–1959)
Parlare di Hamaya significa ricostruire il passaggio da un linguaggio urbano e aerofotografico a un documentarismo etnografico che, per densità formale e rigore metodologico, resta un unicum nella storia della fotografia giapponese del XX secolo. Autodidatta fin da adolescente, entrò nel 1933 come fotografo aeronautico presso il Practical Aeronautical Research Institute e, poco dopo, alla Oriental Photo Industry Company, prima di mettersi in proprio come freelance (1937). Questa sequenza è determinante: l’addestramento aerofotografico gli impose procedure di calcolo dell’angolo di ripresa, controllo della parallasse, stima delle distanze focali equivalenti con riferimento al formato negativo impiegato e disciplina nella lettura della luce in condizioni di forte contrasto, tipiche dell’atmosfera vista dall’alto. Quella grammatica di precisione si rifletterà in seguito tanto nella mappatura topografica dei villaggi del Giappone del Nord quanto nella chiarezza compositiva dei suoi paesaggi invernali.
Nel 1935 acquistò la sua prima Leica, strumento che, con l’otturatore a tendina in stoffa e telemetro accoppiato, gli garantiva rapidità, silenziosità e ottiche luminose in 35 mm; già l’anno successivo pubblicò su Home Life e, fra il 1937 e il 1945, operò come freelance a Tokyo. La scelta del formato 24×36 non fu soltanto pragmatica: in una capitale affollata, il mirino della Leica consentiva composizioni a distanza ravvicinata, tempi rapidi e profondità di campo controllabili per isolare i soggetti nello spazio urbano modernista che egli osservava con curiosità e sospensione di giudizio.
Nel 1939 un incarico lo portò nella regione costiera del Mare del Giappone (Niigata, Toyama e altri distretti). Lì maturò un cambio di paradigma: dalla “cronaca” cittadina passò a un progetto di lungo periodo sul rapporto tra uomo e clima secondo la nozione di “Fūdo” (ambiente/clima) che svilupperà pienamente negli anni Cinquanta. Il suo protocollo operativo si fece allora eminentemente etnografico: residenza prolungata nei villaggi, partecipazione ai rituali, stesura di schedature su costumi, calendario agricolo, itinerari stagionali e lessici locali, costruendo sequenze visive con logica tipologica (mestieri, gesti, strumenti) e cronologica (dall’inverno allo scioglimento delle nevi). Questa metodologia, che intrecciava interviste informali e note di campo con riprese su tre piani — panoramica (contesto), media (gruppo), ravvicinata (gesto) — definì la sua cifra “scientifica” applicata alla fotografia.
Fra il 1942 e il 1945 collaborò alla rivista Front (Tōhō-sha), sofisticato apparato propagandistico che utilizzava rotocalco fotogravure, layout fototestuali e montaggi ispirati alle riviste d’avanguardia europee e sovietiche. L’esperienza, pur controversa, rafforzò le sue competenze redazionali e tipografiche: selezione dei grigi in profondità, uso del retino fine, calibrazione del contrasto locale per la stampa in profonda fotoincisione (deep gravure), tutte competenze che saranno decisive nei suoi libri.
Nel dopoguerra, immerso nel Tōhoku invernale, Hamaya sviluppò una tattica tecnica adatta alla “neve alta”: esposimetro esterno, compensazioni positive per l’abbagliamento (frequente +1 EV per evitare grigi sporchi), filtri gialli o arancio per comprimere la brillantezza del manto nevoso e restituire micro-contrasto nelle trame dei kimono e nelle fibre dei minobōshi in paglia. Quando operava in medio formato (TLR come Rolleiflex o equivalenti), sfruttava l’ampio negativo 6×6 per transizioni tonali lunghe e stampe in gelatina ai sali d’argento dalla grana sottilissima; sul 35 mm privilegiava ottiche di media focale (50–90 mm) per ritratti ambientati, con diaframmi attorno a ƒ/5,6–ƒ/8 per un equilibrio tra piani e isolamento del volto nell’aria spessa dei villaggi costieri. Sebbene i modelli di corpo macchina e obiettivi specifici non siano sempre inventariati nelle fonti pubbliche, la pratica con Leica è attestata per gli anni Trenta e Quaranta; la resa tonale e il formato delle stampe degli anni Cinquanta mostrano con verosimiglianza un uso combinato di 35 mm e medio formato coerente con i risultati di tessitura tonale che vediamo nelle edizioni gravure di Yukiguni e Ura Nihon.
Nel 1955 Edward Steichen selezionò una sua fotografia per la storica mostra The Family of Man al MoMA, attestandone il respiro umanista e la leggibilità universale dei soggetti. La scelta non fu solo curatoriale, ma segnalò la maturità narrativa raggiunta nelle serie del “Nord innevato” e annuncia la fase dei grandi fotolibri costruiti per sequenza e respiro tipografico.
La sua architettura visiva, al di là del mito del “realismo puro”, è profondamente costruita: allineamenti orizzontali delle linee di costa, ripartizione ternaria dei piani (cielo–mare/neviera–figura), altezza del punto di vista calcolata per dare scala all’evento umano contro un campo climatico ostile. Saggi recenti hanno discusso come in Snow Land convivano nostalgia agraria e critica della modernità, in un dialogo teorico con Watsuji Tetsurō (il clima come matrice culturale) e l’ethos del documentarismo sociale giapponese pre-Provoke: gli strumenti “freddi” dell’aerofotogrammetria e della redazione propagandistica vengono ri-orientati verso un umanesimo analitico che non concede all’enfasi retorica.
Concetti chiave di questa prima fase sono dunque Fūdo come cornice, sequenzialità come metodo narrativo, precisione espositiva come etica della testimonianza, e stampa in rotocalco come veicolo privilegiato di diffusione. In tutti i casi, l’elemento tecnico non è accessorio: disegna il campo d’azione di un autore che si muove tra misurazione e partecipazione, diagramma e rituale.
Dalle serie “innevate” alla protesta: libri, processi di stampa e sistemi di ripresa (1956–1969)
Il 1956 segna l’uscita di “Yukiguni / Snow Land” (Mainichi Shinbunsha): un libro in fotogravure a piena pagina, 138 pagine e 129 immagini, progettato per una lettura in cui i pieni neri si appoggiano a carte porose e i grigi intermedi, grazie al retino profondo del gravure, “respirano” con una morbidezza difficilmente ottenibile con la stampa offset dell’epoca. La scelta della fotogravure non fu estetismo: su soggetti neve–pelle–paglia–legno, la stampa in profondità consente gradazioni sub-pelle (guance arrossate dal freddo) e microcontrasti nei fiocchi di neve in sospensione, mantenendo densità massime senza bloccare i dettagli. Dal punto di vista del flusso di lavoro, Snow Land implica un editing binario tra tavole orizzontali di respiro paesaggistico e strette verticali su mani, volti, utensili; i capitoli stagionali articolano la cadenza del lavoro agricolo e dei riti, mentre il ritmo delle aperture alterna doppie a respiro ampio e singole serrate per segnare accenti etnografici (un costume, un utensile) nel continuum narrativo.
Nel 1957 pubblica “Ura Nihon / Japan’s Back Coast” (Shinchōsha), libro di grande formato (circa 27×36 cm), tela e sovraccoperta in cofanetto, con prefazione di Yasunari Kawabata in alcune edizioni e un indice dettagliato con legende e commenti. La resa tipografica, ancora in gravure, enfatizza linee di costa, maree, peschiere: i neri “molli” delle barche e gli orizzonti lattiginosi sono calibrati su curve caratteristiche che privilegiano le ombre profonde senza perdere lo “spolvero” della luce di mare. La sequenza è meno “etnografica” e più pittorica: orchestrazione dei pieni e vuoti, dinamica della diagonale (promontori, moli, scogliere), campiture minime dove una figura minuta rompe la monotonia del bianco e del grigio. È qui che la sua “scuola aerea” riemerge in inquadrature alte e vedute a piombo sui reticoli di risaie e sulla mosaica degli orti.
Dal punto di vista strumentale, i corpi a telemetro restano ideali per ritmi lenti e luce diffusa degli interni rurali, mentre le TLR (Rolleiflex 2.8/3.5) garantiscono un negativo 6×6 capace di restituire i velluti tonali dei visi e dei tessuti. L’ottica Planar/Xenotar 80 mm classica delle TLR opera a ƒ/4–ƒ/8 con tempi “alti” resi possibili dall’appoggio al corpo e dal mirino a pozzetto, che favorisce gesti non invasivi; la Leica è preferibile in esterno con vento e neve, dove la compattezza e la tenuta al freddo giocano a favore. Anche senza inventari completi di attrezzatura, il dato storico della sua pratica Leica e la qualità dei negativi e delle stampe pubblicate in quegli anni consentono di dedurre un ecosistema misto fra 35 mm e medio formato, coerente con gli esiti tipografici descritti.
Nel 1960 Hamaya è a Tokyo per documentare le manifestazioni contro il rinnovo del Trattato di Sicurezza USA–Giappone (Anpo). Il libro “Ikari to kanashimi no kiroku / A Record of Anger and Grief” adotta un lessico più nervoso: tempi rapidi, grani più evidenti nelle stampe a contrasto, linee di forza date da cartelli, bastoni, ombrelli, strappi visivi ottenuti anche con mosso intenzionale. La sequenza non è più ciclica come nelle stagioni, ma crescendo: dal raduno alla tensione, dall’urto al disincanto politico. Qui il telemetro 35 mm è protagonista, con focali 35–50 mm per entrare nel corpo della folla e tempi nell’ordine di 1/250–1/500 per congelare gesti e collisioni; l’esposizione punta a nettezza di silhouette per una leggibilità immediata in pagina. Il progetto evidenzia la polivalenza tecnica dell’autore: stesso controllo tonale, ma dinamica completamente diversa, in cui l’etica della testimonianza prevale sull’“atlante” etnografico.
Nel layout del libro di protesta rientrano strategie editoriali sperimentate: soglie (pagine di titolo come “respiro” prima del rumore), anti-ritmo (interruzioni con immagini quasi vuote), capitelli tipografici minimali per non interferire con la forza fotografica. Se Snow Land e Ura Nihon lavorano sull’“immanenza del clima”, Record of Anger and Grief lavora su “urti e vettori”; in entrambi i casi, la tecnica – dalla misurazione della luce alla stampa – è strumento di pensiero.
Nel 1955 una sua immagine entra, come detto, in The Family of Man, e nel 1960 Hamaya diventa associate di Magnum Photos, a sancire la rilevanza internazionale del suo lavoro. Negli anni successivi la sua attenzione si volgerà di nuovo al paesaggio (serie su Nihon Rettō / Landscapes of Japan, 1964; Monte Fuji, 1978), proseguendo quell’indagine su morfologia e cultura che era embrionale già nelle prime ricerche aeree.
Un’osservazione finale su stampa e supporti: i fotolibri di Hamaya degli anni Cinquanta sono un laboratorio tipografico. La scelta della gravure favorisce neri profondi e mezzi toni vellutati; la carta (spesso non patinata a fibre lunghe) assorbe l’inchiostro e restituisce superfici “calde”, in sintonia con la materia di legno, paglia, neve. Questi parametri, discussi dagli storici del photobook come fattori decisivi di “voce” autoriale, spiegano perché Snow Land e Ura Nihon siano entrati a pieno titolo nella storia del fotolibro del Novecento.
Opere principali, cicli, libri e ricezione critica (1956–1990)
L’opera di Hamaya è un corpus stratificato che tiene insieme serie di lungo periodo, libri-manifesto e antologie retrospettive. Tre assi lo attraversano: l’etnografia della neve, la costa “di retro” e la piazza politica. A questi si affiancano paesaggi ad alta intensità climatica e ritratti di intellettuali giapponesi. La storia editoriale delle sue opere è particolarmente rilevante perché, nella tradizione fotografica giapponese, il fotolibro è medium primario: è lì che si consolidano sequenze, ritmi, testi e paratesti (prefazioni, glosse, indici), e che si decidono processi di stampa capaci di determinare semantica e timbro delle immagini.
“Yukiguni / Snow Land” (Mainichi Shinbunsha, 1956) è l’opera che lo consacra internazionalmente. Oltre ai dati materiali già ricordati, è importante leggere il libro come un dispositivo di conoscenza: la prefazione colloca l’osservatore nel tempo agricolo del Nord; la prima sezione stabilisce una geografia morale con vedute alte e campiture di bianco che “inghiottono” le sagome; le sezioni interne oscillano tra lavoro (risaie, filatura, pesca invernale), rituali (Capodanno, nozze) e infanzia (i giochi sulla neve), componendo una anatomia della comunità. La metrica delle immagini segue spesso la legge dell’ellisse: un oggetto-risorsa (zappe, fasci di riso) apre la scena, la figura interviene a metà, lo sfondo chiude con linee oblique che fissano l’equilibrio. La stampa in gravure restituisce tessiture sottili del ghiaccio e pelli screpolate, elementi che, in un offset dell’epoca, si sarebbero persi. La prima edizione è oggi rarissima, spesso individuabile per cofanetto e sovraccoperta; le schede delle librerie antiquarie confermano formato e numero di pagine, utile per la filologia dell’oggetto.
“Ura Nihon / Japan’s Back Coast” (Shinchōsha, 1957) lavora su un lessico marittimo. Una parte della critica sottolinea come qui Hamaya de-enfatizzi l’aspetto “etnografico” per accentuare la forma: orizzonti orfani, barche come grafemi neri, promontori in diagonale. L’edizione di grande formato, con tessuto di copertina e calligrafia sul cofano, include postfazione bilingue e indice con glosse; in alcune tirature appare la prefazione di Kawabata, che ancor più insiste sulla poetica del margine. Anche questo volume è oggi ricercatissimo dalla bibliografia del fotolibro; le schede d’asta permettono di verificare tirature, stato di conservazione e apparati.
“Ikari to kanashimi no kiroku / A Record of Anger and Grief” (Kawade Shobō Shinsha, 1960) è il libro della piazza: la sequenza cresce come un adagio furioso, con campi larghi di massa e strette su mani, bocche, occhi. Il tono è dichiarativo ma disciplinato, evitando il compiacimento del gesto eroico; l’editing riduce l’apparato testuale al minimo e sposta tutto sul ritmo visivo. L’estetica è già quella di un reportage “concerned”, che lo collocherà nella famiglia spirituale di Magnum. Alcune schede librarie contemporanee registrano prezzi e condizioni delle copie con obi originali, a riprova dell’interesse collezionistico.
Accanto a questo trittico, Hamaya pubblica titoli che ampliano il raggio d’azione: “Nihon Rettō / Landscapes of Japan” (Heibonsha, 1964) è un atlante paesaggistico con attenzione a geologia, morfologia, climi, dove la scala torna ad essere la chiave interpretativa; “Mount Fuji: A Lone Peak” (1978) concentra l’osservazione sul vulcano-simbolo, orchestrando profili, conicità e meteorologie variabili con grande rigore tonale. A monte, restano importanti anche titoli degli anni Quaranta e Cinquanta — come “Senkō shashinjutsu” (1941), manuale sulla fotografia con flash — che testimoniano la consapevolezza tecnica del giovane Hamaya.
Sul versante istituzionale, la presenza in The Family of Man (1955) e l’ingresso in Magnum (1960) certificano la riconoscibilità internazionale; gli Infinity Awards dell’ICP (1986) e l’Hasselblad Award (1987/88) consolidano la sua collocazione nel canone. Le schede dei musei e fondazioni — come il National Museum of Asian Art e la Hasselblad Foundation — ribadiscono i nuclei tematici e le linee temporali della sua produzione.
È utile ricordare alcune mostre e retrospettive che, specie fuori dal Giappone, hanno rifocalizzato la lettura di Hamaya. La Getty ha affiancato il suo lavoro a quello di Kansuke Yamamoto in “Japan’s Modern Divide” (2013), sottolineando il doppio binario documentario/avanguardistico nel modernismo fotografico nipponico; il Setagaya Art Museum ha scandagliato gli anni ’30–’60 con una rassegna sulle origini del suo stile; contributi critici su post (MoMA) e riviste accademiche hanno esplorato ambivalenze tra umanesimo e modernità nelle sue immagini, specialmente nella fotografia post-occupazione. Queste letture confermano che la complessità tecnica dell’opera — scelte di processo, formati, stili di stampa — è inscindibile dal campo semantico (clima, rito, lavoro, conflitto).
Quanto agli aspetti tecnici “di banco”, la pratica di Hamaya rivela una liturgia del negative care: conservazione in buste di carta senza acidi, controllo dell’umidità in ambienti costieri, preferenza per sviluppi compensatori quando la neve imponeva gamma dinamica estrema; nelle stampe, una curva a S delicata per dare corpo alle alte luci senza chiudere le ombre. Nelle edizioni in gravure, i cliché sono incisi per sostenere campiture omogenee (cieli lattiginosi) e microstrutture (paglia, pelo di pellicce, grana della pelle). Dettagli come bordo nero di ripresa o sprocket non sono protagonisti; a dominare è l’immagine “piena” che occupa la pagina con autorità tonale, coerente con un’idea di fotografia come scrittura di clima.
Nel suo percorso internazionale Hamaya viaggia e fotografa anche fuori dal Giappone (Cina, Europa, Nord America, Nepal, Australia, Algeria), ma, rispetto ad altri colleghi di Magnum, mantiene un baricentro interno: la sua “mondialità” si costruisce esportando il particolare giapponese e un metodo capace di legare microfisica del gesto e macro-morfologia del territorio. È questa la coerenza che spiegano tanto le antologie ICP quanto le schede di galleria.
Riconoscimenti e appartenenze. Il certificato Magnum del marzo 1960 ufficializza l’ingresso di Hamaya nella cooperativa; quattro decenni più tardi, le istituzioni museali e accademiche — da ICP a Hasselblad e ai musei giapponesi — continuano a riproporne il lavoro. Tale continuità testimonia la tenuta tecnica e concettuale di un’opera in cui metodo, stampa e sequenza sono indissociabili dal tema.
Bibliografia essenziale delle opere
Yukiguni / Snow Land (Mainichi Shinbunsha, 1956): gravure su carta non patinata, sequenza stagionale; 138 pp., 129 immagini; formato circa 30×26 cm; cofanetto e sovraccoperta nelle tirature complete. La profondità dei mezzitoni è un caso di scuola per la resa della neve su corpi e tessuti.
Ura Nihon / Japan’s Back Coast (Shinchōsha, 1957): grande formato 27×36 cm, tela con sovraccoperta e cofanetto, indice con glosse; 50 tavole (in alcune edizioni) con 5 a colori; postfazione in inglese. Linea di costa e ritmi della pesca incidono la pagina con equilibri di pieni/vuoti.
Ikari to kanashimi no kiroku / A Record of Anger and Grief (Kawade Shobō Shinsha, 1960): reportage di piazza con telemetro 35 mm, tempi rapidi, contrasto alto; edizioni con e senza obi; sequenza a crescendo.
Nihon Rettō / Landscapes of Japan (Heibonsha, 1964): atlante paesaggistico; ritorno a vedute alte e morfologie; importante per capire la traslazione del metodo etnografico in geografia visiva.
Mount Fuji: A Lone Peak (1978): monografia sul Fuji-san; studi su strati atmosferici, profilo conico, nuvole lenticolari; stampa calibrata per alte luci.
A questi si aggiungono lavori e manuali: Senkō shashinjutsu (1941) sul flash; Children in Japan (1959); raccolte e antologie successive. In sede di storia del fotolibro, le opere di Hamaya compaiono nelle sintesi di Parr & Badger, soprattutto per il ruolo esemplare di Snow Land e Ura Nihon nel definire forma-libro e identità tonale del documentario giapponese
Fonti
- Scheda Wikipedia con cronologia e bibliografia essenziale
- International Center of Photography – profilo e Infinity Award 1986
- National Museum of Asian Art – biografia e linee di lavoro (Yukiguni, Ura Nihon, Nihon Rettō)
- Michael Hoppen Gallery – profilo, mostre e riconoscimenti internazionali
- Hasselblad Foundation – pagina del premio a Hamaya
- Magnum in Motion / Slate – sintesi biografica e cronologia delle serie
- Parr & Badger, The Photobook: A History, vol. I – contesto storico-editoriale dei fotolibri giapponesi
- Ross Tunney, Imaging the Rural – lettura teorica di Snow Land
- Setagaya Art Museum – retrospettiva sulle fotografie 1930s–1960s
- Kyoto Journal, Japan’s Modern Divide – intervista ai curatori Getty
Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.