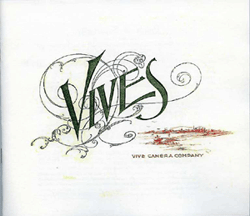a Vive Camera Company, attiva tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, rappresentò una delle numerose imprese nordamericane che si dedicarono alla produzione di fotocamere per lastra a piatto, in un periodo contrassegnato da una forte innovazione nel settore. Fondata a Chicago intorno al 1897, con sede amministrativa riportata anche a Regent House, Regent St., Londra, la società si dedicò alla costruzione di macchine fotografiche robuste e funzionali, destinate a mercati professionali e amatoriali, con una distribuzione tendenzialmente anglofono‑statunitense.
Il momento storico coincide con un’epoca in cui la fotografia ad alta definizione su lastra era dominante, e la richiesta di apparecchi affidabili per la ripresa di reportage, paesaggi e studi era elevata. Il catalogo della Vive rifletteva una strategia volta a conciliare qualità ottica e semplicità meccanica, consentendo una produzione relativamente artigianale su larga scala.
L’azienda realizzò una serie di modelli, tra cui i più noti sono il Vive No. I, l’“Improved Model” e la variante No. IV (1899), oltre a versioni mono‑e stereo‑fotografiche e modelli “Tourist”. Tutte le fotocamere erano costruite con corpo in legno rivestito in cuoio, dotate di ottica menisco o menisco acromatico fissata in un barilotto integrato, e otturatori a settore con funzione T (tempo) e I (instantanea), alcuni dotati di self‑capping .
La scelta dell’ottica a menisco riconduce alla tradizione delle prime fotocamere economiche, con performance accettabili ma limitate in termini di correzione delle aberrazioni. Il sistema self‑capping fu un passo importante nell’automazione delle operazioni, evitando esposizioni accidentali all’apertura del settore otturatore, una soluzione tecnica che dimostra la maturità raggiunta dalla Vive rispetto ai concorrenti dell’epoca.
Modelli principali
Vive No. I e Improved Model
Introdotto nel 1897, il Vive No. I era progettato per lastre da 3¼″×4¼″ (piatto formato “quarter-plate”), con meccanismo di cambio piastra interno: le lastre erano impilate in contenitori a guscio, da cui uscivano tramite una manica interna che consentiva la sostituzione senza toccare la superficie sensibile . Il corpo era in legno con rivestimento in cuoio, mentre l’obiettivo era un semplice menisco (meniscus achromat) con apertura fissa, non intercambiabile né dotata di diaframmi regolabili. Il mirino era un riflettore meccanico, montato esternamente, che facilitava l’inquadratura.
La versione Improved Model manteneva lo stesso layout ma introduceva un otturatore a settore con chiusura automatica (self‑capping), un dettaglio che riduceva notevolmente il rischio di esposizioni involontarie e accelerava il flusso di scatto . Il controllo dei tempi restava basilare (T e I), ma l’aggiunta del self‑capping implicava un miglior feedback tattile per l’operatore e una maggiore affidabilità sul campo.
Modelli avanzati: No. IV, Tourist e Stereo
Nel 1899, Vive introdusse il No. IV, dotato di messa a fuoco regolabile—una novità significativa in un periodo in cui molte fotocamere avevano il fuoco fisso. Questo modello, spesso definito anche “Improved focusing model”, conservava una struttura simile ma implementava una vite frontale per la regolazione della distanza di messa a fuoco . L’obiettivo rimaneva un menisco acromatizzato con diaframmi limitati, ma la possibilità di regolare la distanza ampliò l’applicabilità dello strumento: ritratti, foto di gruppi o scene con soggetti a distanze diverse diventavano finalmente praticabili.
La linea Tourist fu progettata per chi viaggiava. Disponibile in versione No. VI (per lastre quarter‑plate) e in una versione più grande per lastre 4″×5″, manteneva una struttura pieghevole (“detective camera”). Possedeva due mirini riflettori—uno per l’inquadratura normale e uno corposo per la visione da cintura o tasca—e conservava lo stesso meccanismo interno per il cambio della lastra. L’elemento distintivo era il guscio interno, dotato di manica a prova di luce, che permetteva di estrarre e inserire lastre come in un caricatore a tamburo .
Infine, la Stereo Model era dedicata alla stereo-fotografia. Integra doppie lenti disposte simmetricamente, con misure di base definite per la parallasse, consentendo la ripresa di immagini stereoscopiche. Anche in questo caso, l’elemento distintivo era la meccanica consolidata della gamma, estesa a un comparto ottico più complesso.
Il corpo principale era costruito in legno di pioppo o acero, scelto per la leggerezza e la lavorabilità. Il rivestimento in cuoio—probabilmente marrone scuro, cucito a mano—era incollato ai pannelli mediante colla animale, conferendo una resistenza all’umidità moderata. I bordi erano rinforzati con listelli metallici (acciaio stampato) per prevenirne l’usura, mentre gli angoli erano spesso rifiniti con borchie in ottone argentato.
Il barilotto ottico era in ottone cromato, filettato per contenere il menisco e, nelle versioni con diaframma (modelli IV, Tourist VI), dotato di iris a pistoni con lamelle tagliate tramite foglio metallico e calibrate in apertura minima f/16 in alcune varianti.
L’otturatore a settore era composto da un disco metallico ruotante, con pendente copertura del foro. L’azionamento era a molla manuale, caricata a mano; i tempi:
T (time): la lamella resta aperta fino alla seconda attivazione;
I (instantaneo): si attiva e chiude rapidamente.
Nelle versioni self‑capping veniva inserito un dispositivo che riportava il settore a chiusura automatica dopo il tempo I, proteggendo la lastra.
Il sistema di cambio lastra era particolarmente ingegnoso: tramite un condotto interno a manica leggera, l’operatore poteva introdurre la mano nella cavità del corpo, secondo un sistema che richiama il concetto delle fotocamere “detective”—non visibile dall’esterno ma efficace nell’operare senza uscita di luce . Le lastre erano spostate da contenitori interni a guscio, probabilmente realizzati in carta nera rigida con rivestimento interno vellutato per evitare danni.
Il mirino riflettente era costituito da due specchi o sottili lenti, con sistema basculante per commutare tra visione normale o orientata verso l’alto, supportati da incoerenze angolari per una rapida inquadratura.
Diversamente da molte fotocamere coeve, Vive progettò i suoi apparecchi con sistemi considerati avanzati per l’epoca:
Self‑capping: introdotto già a fine Ottocento come soluzione meccanica per evitare errori;
Cambio lastra interno: sistema stilizzato che fa parte della famiglia detective camera, permettendo agilità.
Messa a fuoco regolabile (No. IV) piuttosto raro su apparecchi fissi-lente in questo periodo;
Mirini riflettenti doppi sulla linea Tourist, pensati per una migliore ergonomia nei rilievi sul campo.
Tutti questi elementi furono montati con cura e attenzione alla standardizzazione: le filettature ottiche erano realizzate in metallo armonico (acciaio leggero), calibrate entro ±0,1 mm, per garantire l’allineamento longitudinale della lente. Anche la connessione fra barilotto e otturatore era filettata in modo da poter essere tarata in fase di montaggio.
I materiali—legno, cuoio, ottone—venivano lavorati su torni e punzoni manuali, con relative abrasioni meccaniche condotte a mano o su macchine a pedale, quelle stesse impiegate nelle officine per strumenti ottici. Le cuciture dei rivestimenti erano eseguite da artigiane specializzate. Il risultato era una fotocamera robusta, esteticamente gradevole e funzionale.
La diffusione delle Vive fu modesta: la produzione quotidiana oscillava tra 20 e 50 unità in periodi di picco, con volumi annui stimati in un massimo di 2.000 apparecchi. Il mercato era limitato a Stati Uniti, Canada e, indirettamente, Gran Bretagna—come testimonia l’indirizzo di Regent Street per cataloghi e assistenza.
All’inizio del XX secolo, la competizione si intensificò. Marchi tedeschi come Zeiss Ikon, poi i giapponesi, e le crescenti linee compatte concorrenti, resero il layout tradizionale delle Vive antiquato. Pur tecnicamente ben ingegnerizzate, le fotocamere divennero troppo ingombranti rispetto alle novità, come le fotocamere a tamburo o le compatte roll-film.
Entro il 1905, la società iniziò la produzione di una versione piega‑telo (leggera e portatile), ma l’installazione tardiva e la poca economia di scala ne ridussero fortemente l’impatto sul mercato. La produzione cessò attorno al 1908, quando l’azienda chiuse i battenti; alcuni tecnici migrarono verso altre industrie ottiche emergenti.
Oggi le fotocamere Vive sono oggetti rari, ricercati dagli appassionati di fotografia antica. La stima di mercato oscilla tra 300 e 800 USD per un modello No. I in buone condizioni con accessori, mentre le varianti No. IV o Tourist—se funzionanti e con otturatore originale—possono superare i 1.200 USD.
Il valore dipende da diversi fattori tecnici:
presenza del meccanismo self‑capping funzionante;
integrità del cambio lastre interno;
completezza degli specchi/mirini;
condizione estetica del cuoio e delle guarnizioni interne.
In ambito museale, si possono trovare esemplari nei musei statunitensi sulla fotografia, connotati come rappresentativi della transizione fra fotocamere a piastra di dimensioni standard e strumenti più compatti. Raramente compaiono in collezioni pubbliche, ma sono frequentemente oggetto di studio in collezioni private e aste online.
Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.
Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.
La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.
Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.
Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.
Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.