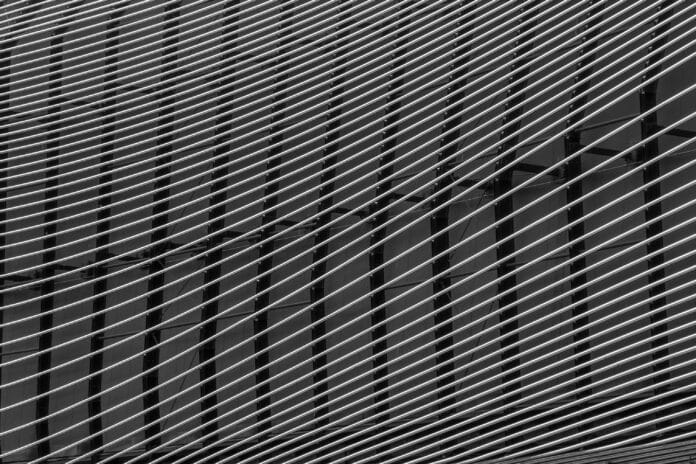Nel primo decennio del Novecento la fotografia americana si trovava in uno stato di fermento che oscillava tra visioni pittorialiste e sperimentazioni di avanguardia. I sostenitori del pittorialismo ricercavano atmosfere morbide e vibrazioni tonali, spesso ottenute con ottiche a fuoco dolce e manipolazioni in camera oscura, mentre un ristretto nucleo di fotografi guardava con sospetto a quell’interpretazione romantica, reputandola inadatta a esprimere la potenza intrinseca del mezzo fotografico. Il clima culturale tra le due guerre mondiali favorì un riavvicinamento al rigore formale occidentale, grazie anche all’influenza delle correnti moderniste europee che mettevano al centro la purezza delle linee e la chiarezza delle forme. A San Francisco, nel novembre del 1932, sette personalità si riunirono con l’intento di codificare un nuovo linguaggio fotografico, fondato su principi scientifici: nacque così il Gruppo f/64, intitolato all’apertura di diaframma più chiusa disponibile sulle ottiche da grande formato dell’epoca. Quel diaframma estremo consentiva di ottenere una profondità di campo praticamente infinita, capace di rendere nitide tutte le parti della scena, dal primo piano all’infinito, senza ricorrere a sfocature evocative. L’intento dichiarato era mettere a disposizione di un pubblico più ampio un’immagine che fosse fedele alla realtà, esente da artifici pittorici e manipolazioni emotive.
I primi incontri si svolsero negli studi dei fotografi e nelle sale della galleria M.H. de Young Memorial Museum, dove vennero esposte le prime stampe ufficiali di f/64. Le foto non erano presentate in cornici decorative ma montate semplicemente su carta di qualità, per mettere in risalto l’omogeneità della serie. Il rigore espositivo si rifletteva nella selezione dei soggetti: paesaggi della California settentrionale, scorci urbani e dettagli architettonici, tutte scelte per mostrare la validità del metodo su soggetti di varia natura. L’esperienza quotidiana sul territorio, tra brughiere di scogli californiane e vette granitiche del parco di Yosemite, servì a sperimentare la risposta delle ottiche chiuse ai valori tonali più difficili, mentre nelle periferie urbane si misurava l’effetto di controluce e ombra. Fu un approccio sperimentale, basato su prove e misure: esposizioni cronometrate, misurazioni con esposimetri a sfera, test di sviluppo e stampa calibrati al grado Celsius. Il gruppo non pubblicò subito un manifesto formale, preferendo far parlare le immagini e lasciare che fossero i curatori delle mostre e i critici specializzati a riconoscerne il valore innovativo.
Fondamenti ottici: diaframma chiuso e profondità di campo
Il cuore tecnico dell’operazione stava nell’apertura f/64, che su obiettivi da grande formato raggiungeva diaframmi fino a f/64 o f/90 su ampi lavori personalizzati. Questo valore di diaframma rappresentava il limite estremo della chiusura, in cui il circolo di confusione risultante era così piccolo da garantire nitidezza uniforme. Ciò avveniva a patto di impiegare ottiche di eccellenza, progettate con vetri correttivi capaci di eliminare le aberrazioni sferiche e cromatiche. Alcuni scelgono vetri speciali a bassa dispersione ottica (ED) e rivestimenti antiriflesso all’ossido di magnesio, capaci di ridurre al minimo la diffrazione. In quei decenni si ricorreva a ottiche anastigmatiche ad alta risoluzione, spesso di fabbricazione europea (Zeiss, Goerz, Ross), montate su corpi macchine in mogano o alluminio brunito. Il risultato pratico era un’immagine di dettagli estremi: le venature del legno, le crepe delle rocce, le nervature delle foglie, tutto veniva restituito con chiarezza quasi clinica.
Il diaframma chiuso non solo garantiva massima profondità di campo, ma favoriva anche un contrasto più elevato nelle stampe finali. Un’apertura estrema riduceva infatti la luce indiretta che attraversava l’ottica, migliorando la definizione dei bordi e il pettinamento dei chiaroscuri. Questa qualità tecnica fu sfruttata dai membri di f/64 per esaltare le texture del paesaggio, accentuare le ombre intricate e delineare con precisione i profili architettonici. I tempi di posa con f/64 erano relativamente lunghi: fino a diversi secondi in pieno sole, ma con emulsioni panchromatiche, dall’ISO 25 all’ISO 50, riuscivano a rimanere entro durate accettabili per scene statiche. Oggi sembri tecnologicamente anacronistico, ma all’epoca rappresentava un bilanciamento perfetto tra velocità di lavoro ed eccezionale qualità compositiva.
Strumenti e materiali: fotocamere grande formato, emulsioni e ottiche
La scelta del supporto era altrettanto cruciale. Gran parte del lavoro si svolgeva su fotocamere a banco ottico di grande formato, i modelli più diffusi erano quelli 8×10 pollici (20×25 cm) e 5×7 pollici (13×18 cm), dotati di soffietto metallico e meccanismi di spostamento per shift e tilt. Il banco ottico permetteva di controllare la prospettiva e la messa a fuoco con precisione, grazie allo spostamento del modello rispetto al vetro smerigliato e al piano della lastra. Gli operatori utilizzavano un treppiede a collo d’oca in acciaio, con componenti smontabili per inserirli nelle borse da campo. Il livello centesimale e le livelle a bolla venivano impiegati per assicurare l’orizzontalità del piano focale, requisito indispensabile per applicare correttamente il diaframma f/64 su superfici piane come lastrici rocciosi o muri.
Le lastre di vetro dovevano essere pulite con soluzioni alcoliche e maneggiate con guanti di cotone bianco per non lasciare impronte. L’emulsione era di tipo gelatino-bromuro di argento, preparata in laboratorio con stadi di maturazione controllata per favorire cristalli di dimensioni ridotte e uniformi, in grado di garantire grana minima e ampia gamma dinamica. Sul campo venivano inserite cassette stagne per evitare infiltrazioni di luce, poiché anche una piccola perdita poteva compromettere la resa dei dettagli. I rulli di pellicola 120 o 35 mm non furono mai apprezzati dai puristi di f/64, che preferivano la piastra rigida per la sua planarità e assenza di deformazioni in fase di sviluppo.
Gli obiettivi adottati spaziavano dal grandangolo al tele per panorami ravvicinati o isolati. I grandangoli da 90–120 mm su 8×10 garantivano un ampio angolo di campo, ideale per paesaggi montani e vallate, mentre i teleobiettivi da 360 mm permettevano dettagli su rocce o elementi architettonici a distanza. Lenti con schema a quattro o cinque gruppi anastigmatici riducevano le aberrazioni e consentivano di chiudere al diaframma f/64 senza generare ombre indesiderate o vignettatura. Ogni lente veniva pulita e calibrata periodicamente in laboratorio ottico per mantenere la corretta distanza focale e la planarità della superficie.
Tecniche di esposizione e sviluppo: dallo scatto alla stampa
Prima dello scatto si misurava la luminosità con esposimetri a sfera integrale o a fotocellula CdS. Questi strumenti restituivano valori di luce incidente e riflessa, permettendo di programmare l’esposizione su diaframmi chiusi. Il fotografo selezionava quindi f/64 e calcolava il tempo di posa, che poteva variare da frazioni di secondo a diverse decine di secondi, a seconda delle condizioni. Per scene statiche, come paesaggi montani o strutture architettoniche, ogni secondo aggiuntivo di esposizione aumentava la nitidezza e riduceva il rumore di grana. Il movimento involontario veniva eliminato dalla stabilità del treppiede e dalla scelta di otturatori a tendina in titanio, con rotazione fluida e tempi tarati al centesimo di secondo.
La fase di sviluppo dei negativi avveniva in laboratorio, dove si utilizzavano soluzioni standardizzate di idrochinone e metolo in tampone fosfato o borico, per controllare la reazione e modulare la curva caratteristica del materiale. Il rapporto tra idrochinone e metolo e la temperatura di sviluppo (20 °C) erano mantenuti costanti per garantire uniformità tra diversi scatti. Durante lo sviluppo il tecnico agitava delicatamente il contenitore per favorire l’eliminazione dei residui di bromuro e permettere una formazione regolare della sospensione d’argento metallico. Il fissaggio in tiosolfato di sodio eliminava l’argento non reagito e allungava la vita del negativo, mentre un lavaggio in acqua demineralizzata rimuoveva residui chimici. Le lastre venivano poi asciugate in ambienti a umidità controllata per prevenire deformazioni.
Alla stampa si ricorreva a ingranditori dotati di ottiche anastigmatiche, spesso di terza generazione, in grado di mantenere la nitidezza anche con ingrandimenti elevati. Per gestire il contrasto si inserivano filtri Wratten graduati, variando la quantità di luce blu e verde a seconda della sensibilità della carta. Le carte panchromatiche, prodotte da Kodak o Agfa, offrivano grane fini e risposte tonali lineari, mentre le carte a sviluppo chimico riducevano i tempi di esposizione sotto ingranditore. Lo sviluppo delle stampe richiedeva due bagni: uno al complicato mix di idrochinone e metolo per rendere visibili le immagini, seguito dal fissaggio al tiosolfato al 15 %, quindi da un accurato lavaggio e da un trattamento finale con soluzioni antigoccia per prevenire aloni. Ogni fase era scandita da orologi da camera oscura, perché pochi secondi in più o in meno cambiavano profondamente il contrasto e la resa dei dettagli.
I protagonisti e le loro opere emblematiche
Ansel Adams, tra i fondatori più noti, applicò il Zone System per suddividere la scala tonale in dieci zone di grigio, facilitando la previsione del risultato finale. Le sue fotografie dei parchi nazionali, in particolare Yosemite e Kings Canyon, presentano montagne granitiche scolpite da luci oblique e valli avvolte da nebbie che si dissolvono in gradazioni sottili. Adams prediligeva stampe su carta barytata, in grado di restituire neri profondi e dettagli estremi nelle ombre, e utilizzava spesso una combinazione di espositore a ingranditore e filtri rossi per enfatizzare i nuvoloni.
Edward Weston si dedicò a soggetti naturali ravvicinati: chili di peperoni, conchiglie e foglie diventarono sculture luminose grazie all’apertura f/64 su lastre 8×10. Le sue immagini di “Pepper No. 30” riprendono superfici curve e traslucide, mettendo in evidenza texture e piani di luce. Weston non amava la manipolazione: ogni scatto era pianificato e costruito sul campo, sfruttando le ore migliori della giornata per ottenere contrasti nitidi e delineare forme tridimensionali.
Imogen Cunningham applicò il rigore del gruppo ai ritratti botanici e umani. Le sue fotografie di orchidee mostrano petali e pistilli con definizione scientifica, mentre i ritratti di colleghi e amici mantenevano un equilibrio tra rigore formale e intimità narrativa. Cunningham curava personalmente ogni stampa, dalla scelta della carta gelatinosa ai tempi di sviluppo, seguendo parametri isoterme per garantire uniformità tra serie di stampe anche dopo anni di distanza.
Willard Van Dyke sperimentò esposizioni notturne su paesaggi urbani. I suoi scatti dei ponti di San Francisco, illuminati da lampioni e fari di auto, rivelano scie luminose e riflessi che percorrono le travi metalliche, mescolando rigore tecnico e suggestione del tempo lungo. L’uso di emulsioni panchromatiche e otturatori rallentati consentì di riprodurre fedelmente i toni più caldi delle lampade a gas e dei riflettori, pur mantenendo intatta la struttura formale.
Diffusione della metodologia f/64 e approccio contemporaneo
Dopo il 1935 il Gruppo f/64 cessò formalmente la propria attività, ma i principi di chiarezza oggettiva e precisione scientifica continuarono a influenzare intere generazioni di fotografi. Negli anni Cinquanta e Sessanta la New Topographics e le avanguardie minimaliste raccolsero l’eredità visiva di f/64, adottando la nitidezza estrema come strumento di analisi spaziale. Allo stesso tempo, l’industria ottica sviluppò obiettivi ancor più correttivi e pellicole a grana sempre più fine, spingendo il concetto di risoluzione oltre le 100 linee per millimetro su ingrandimenti a copia. Le fotocamere da 4×5 pollici e 5×7 pollici furono adottate da professionisti del paesaggio in tutto il mondo, mentre il mercato delle lenti vide l’ingresso di vetri extra-bassi in dispersione e rivestimenti multi-strato per ridurre flare e ghosting.
Perfino nell’epoca digitale, l’eredità di f/64 sopravvive nella ricerca di sensori con alta risoluzione e nella tecnica dell’focus stacking, che simula digitalmente la profondità di campo infinita chiudendo virtualmente il diaframma in più scatti. Fotografi contemporanei usano strumenti di precisione (livelle elettroniche, micro-adjustment del sensore e profili colore personalizzati) per ricreare l’approccio metodico dei pionieri di f/64. La divisione tra tecnica e creatività, che il gruppo aveva sfidato dichiarando che un’immagine nitida può essere anche poetica, resta un paradigma di riferimento per chi desidera unire rigore formale e potenza espressiva.
Fonti
I Pittorialisti e il Gruppo F.64 – Olgiate in Foto
Ansel Adams – Grandi-Fotografi.com
Ansel Adams e la fotografia paesaggistica in bianco e nero – Reflexmania
Manifesto of the Group f/64 (1932) – Photography History Blog
Group f/64 Manifesto (1932) – Photography History Blog
Group f.64: Edward Weston, Ansel Adams, Imogen Cunningham… – Mary Street Alinder
Group f/64 – The Metropolitan Museum of Art
Aggiornato Dicembre 2025
Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.