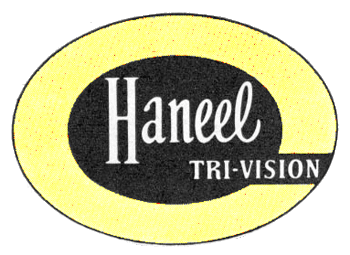La Haneel Camera Company, attiva negli Stati Uniti durante gli anni Quaranta del Novecento, rappresenta un caso emblematico di piccola impresa entrata nella storia della fotografia grazie a un singolo prodotto innovativo, il Tri-Vision, che riuscì per un breve ma intenso periodo a imporsi sul mercato grazie alla combinazione tra ingegno meccanico e semplificazione del processo fotografico. Fondata da Elliott Haneel nel 1941 a Los Angeles, in California, la società nasce in un contesto già fortemente competitivo, dominato da grandi marchi come Kodak e Argus, ma riesce a ritagliarsi uno spazio preciso grazie alla sua proposta originale: una fotocamera triple-lens pensata per l’utente medio, ma dotata di un’architettura tecnica d’avanguardia per il periodo.
Il nome “Tri-Vision” deriva dalla peculiarità costruttiva della macchina: tre obiettivi montati frontalmente su una placca rotante che consentiva di eseguire tre esposizioni consecutive su un singolo fotogramma o su tre sezioni contigue della pellicola. L’idea era quella di offrire un’esperienza parallela a quella delle fotocamere stereo, ma con uno spirito più accessibile e orientato alla fotografia panoramica, piuttosto che a quella tridimensionale.
Il periodo di produzione del Tri-Vision è ristretto tra il 1941 e il 1948, anni segnati dalla guerra e da una crisi dell’industria fotografica americana, costretta a riconvertirsi per esigenze belliche. Nonostante ciò, Haneel riuscì a mantenere la produzione su piccola scala, puntando su un’estetica compatta e su una struttura in metallo stampato e bachelite, materiali leggeri ma resistenti. L’azienda rimase sempre di dimensioni ridotte, caratteristica che le permise di operare agilmente nel mercato nazionale, ma che allo stesso tempo limitò drasticamente le possibilità di espansione globale.
La scelta tecnica del sistema a tre obiettivi fu dettata sia da esigenze di design che da una volontà di semplificare la creazione di immagini panoramiche. A differenza dei dispositivi dotati di meccanismi rotanti complessi o pellicole in formato largo, il Tri-Vision tentava di ottenere un effetto panoramico per somma di immagini statiche. Questo approccio rendeva la macchina attraente per i dilettanti curiosi, ma anche per quei professionisti alla ricerca di una soluzione rapida per la documentazione visiva di ambienti urbani o naturali.
La struttura del Tri-Vision era fondata su un corpo centrale costruito in lega metallica leggera, con inserti in bachelite nera, che conferivano all’oggetto un aspetto moderno e al contempo funzionale. Le dimensioni erano contenute, con una lunghezza complessiva inferiore ai 17 cm, e un peso che si aggirava intorno ai 600 grammi, perfettamente bilanciato per un utilizzo a mano libera. Il design era simmetrico, con le tre lenti frontali disposte su una placca circolare rotante che consentiva la selezione manuale dell’obiettivo da utilizzare per ciascuna esposizione, oppure permetteva l’attivazione sequenziale automatica dei tre otturatori per una raffica panoramica.
Il cuore tecnico dell’apparecchio era costituito dal sistema di tre obiettivi a focale fissa, ciascuno dotato di una lente menisco semplice, con apertura fissa stimata intorno a f/11, e una lunghezza focale di 35mm, compatibile con la pellicola 135 (formato 35mm). L’adozione di tre lenti uguali ma indipendenti garantiva una copertura ampia del campo visivo, con la possibilità di ottenere un’immagine a sviluppo orizzontale di circa 90° totali, divisi in tre fotogrammi contigui. Ogni lente era associata a un proprio gruppo otturatore a scatto singolo, non sincronizzato con flash, ma dotato di un sistema a leva semplice per la tensione manuale.
La meccanica interna era composta da un sistema a cremagliera che guidava lo scorrimento della pellicola in modo sequenziale, accompagnata da un contatore manuale e da un avvolgitore laterale, posto in posizione destra superiore. Non esisteva un sistema di esposizione automatica né un mirino singolo: il Tri-Vision era equipaggiato con tre piccoli mirini ottici dedicati a ciascun obiettivo, sistemati sulla parte superiore del corpo macchina. Questo implicava che il fotografo dovesse allineare ogni scatto manualmente, con una certa difficoltà in fase di composizione se non abituato al processo.
Il caricamento della pellicola seguiva il sistema standard dei rullini 35mm, ma era guidato da un percorso interno suddiviso in tre sezioni, ciascuna corrispondente a un fotogramma. Questo significava che ogni scatto realizzato dalla macchina occupava lo spazio di tre fotogrammi normali sulla pellicola, rendendo il consumo più rapido ma offrendo risultati panoramici unici. L’avanzamento era manuale, ma dotato di un blocco meccanico che impediva l’avanzamento accidentale tra uno scatto e l’altro. I primi modelli non avevano protezione contro la doppia esposizione, problema corretto in una seconda versione prodotta dal 1946.
Il sistema di scatto non prevedeva tempi variabili, ma un’unica velocità standard, presumibilmente intorno a 1/50 di secondo, determinata da un otturatore a lamelle rotative integrato nella montatura di ciascun obiettivo. Questo rendeva la macchina adatta a condizioni di buona luminosità, penalizzandola fortemente in contesti notturni o in interni non illuminati. Nessun modello Tri-Vision venne mai dotato di attacco standard per flash o presa di sincronizzazione.
Il Tri-Vision fu un dispositivo concepito per la fotografia amatoriale, ma finì per suscitare l’interesse anche di settori professionali, in particolare nel campo dell’architettura, del rilievo paesaggistico e della documentazione urbana. Il vantaggio principale della macchina era la possibilità di ottenere una visualizzazione panoramica immediata senza necessità di processi di sviluppo multipli o di assemblaggio successivo in camera oscura. Le immagini ottenute erano già disposte in successione orizzontale sulla pellicola, permettendo al fotografo di osservare e confrontare le porzioni di paesaggio in maniera diretta.
In ambito dilettantistico, la fotocamera trovò un pubblico affezionato tra gli hobbisti e gli appassionati di viaggi, che potevano utilizzare il Tri-Vision per catturare viste ampie di città, coste, paesaggi montani, fiere e situazioni pubbliche affollate, riducendo il numero di inquadrature necessarie. Tuttavia, la sua macchina non era facilmente stampabile nei laboratori standard dell’epoca, poiché le immagini occupavano spazi anomali sulla pellicola. Questo obbligava spesso il fotografo a sviluppare e stampare autonomamente i negativi, o a rivolgersi a laboratori specializzati.
Nonostante i limiti tecnici, la distribuzione sul mercato statunitense fu relativamente efficace grazie alla presenza di agenti regionali e alla pubblicità su riviste di settore come Popular Photography e Modern Photography. Il prezzo al dettaglio era contenuto, collocandosi sotto i 20 dollari, rendendola una delle opzioni più economiche tra le fotocamere con potenziale panoramico. Tuttavia, il ciclo produttivo si interruppe prima della fine del decennio, complice la ripresa post-bellica della produzione fotografica europea e giapponese, che offriva sul mercato modelli tecnicamente superiori, con tempi di scatto variabili, esposimetri integrati e ottiche intercambiabili.
La produzione del Tri-Vision cessò definitivamente nel 1948, anno in cui la Haneel Camera Company venne assorbita da un gruppo industriale operante nel settore ottico, che non proseguì lo sviluppo del marchio. Molti esemplari rimasero in circolazione tra i collezionisti o come strumenti didattici per corsi di fotografia, mentre altri vennero adattati da artigiani locali per utilizzi creativi o come base per fotocamere stereo casalinghe.
Preservazione storica e diffusione nei mercati secondari
L’interesse per il Tri-Vision è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni Settanta e Ottanta, periodo in cui gli storici della fotografia iniziarono a rivolgere maggiore attenzione ai dispositivi cosiddetti “minori” o “alternativi”, troppo a lungo rimasti ai margini della narrazione ufficiale. Il fascino del Tri-Vision risiedeva nella sua natura ibrida: né una vera panoramica, né una stereoscopica, ma un ponte concettuale tra due modi di intendere la visione fotografica. Questa particolarità la rese presto oggetto di studio da parte di università e collezionisti privati, molti dei quali intrapresero restauri accurati e ricerche sulle varianti di produzione esistenti.
Alcuni esemplari furono trovati con piccole differenze nella meccanica dell’otturatore, o con serigrafie differenti sul pannello frontale, segno che la Haneel, nel corso degli anni, sperimentò soluzioni diverse in lotti distinti. Alcuni esemplari rarissimi riportano la scritta “Tri-Vision Deluxe”, sebbene non vi siano differenze sostanziali nelle componenti ottiche. Altri mostrano numeri di serie incisi manualmente anziché stampati, indicazione di una produzione semi-artigianale, che rende ogni macchina un caso quasi unico.
Le aste fotografiche degli anni Novanta hanno visto un aumento significativo delle quotazioni del Tri-Vision, specie se in condizioni operative e accompagnato dalla custodia originale. I prezzi per un esemplare in buono stato possono oggi raggiungere diverse centinaia di euro, e le unità completamente funzionanti sono raramente messe in commercio. Alcuni musei specializzati, come il George Eastman Museum e il Museum of Photographic Arts di San Diego, possiedono modelli esposti nelle sezioni dedicate all’evoluzione delle camere compatte panoramiche del Novecento.
La preservazione tecnica della macchina è oggi complicata dalla reperibilità dei pezzi di ricambio. I meccanismi di scatto, realizzati con materiali ferrosi non trattati, tendono alla corrosione, e le ottiche possono presentare funghi o condensa tra le lenti, problematiche tipiche dei dispositivi in bachelite esposti a variazioni di umidità. Alcuni restauratori, soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone, hanno sviluppato modifiche non invasive che permettono la sostituzione delle lenti mantenendo l’aspetto originale, rendendo il Tri-Vision uno dei pochi modelli vintage con potenziale di riutilizzo in chiave artistica contemporanea.
Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.
Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.
La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.
Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.
Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.
Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.